Non mi sforzerò nemmeno lontanamente di compilare una classifica, che già è stato arduo arrivare a queste sintetiche conclusioni. Quella dei libri preferiti dell’anno è senza dubbio la lista più difficile da assemblare e mi getta puntualmente in un gorgo di dubbio, tentennamenti e FOMO retroattiva. Non si può nemmeno sfuggire a una certa ridondanza, perché se nell’arco degli ultimi dodici mesi ho apprezzato un libro è raro che non l’abbia già dichiarato qua e là, chiacchierandone su Instagram o scrivendone qua sul blog. Insomma, al netto di tutte queste menate, dedichiamoci a quest’impresa di sintesi che risponde alle seguenti coordinate:
- i libri che mi sento di segnalare fra i preferiti dell’anno X non sono necessariamente usciti nell’anno X, anzi. La mia scarsa reattività al nuovo è tendenzialmente assai spiccata, quindi c’è un po’ di tutto – anche se nel 2021 sono caduta dal pero un po’ meno del solito, mi pare.
- i criteri son più “sentimentali” e istintivi che rigorosi e bilanciati. Insomma, per una volta mi concedo il lusso di non pensare a equilibri ferrei tra fumetto, narrativa, saggistica, editori e cento altre interpolazioni possibili.
- nel caso ci siano luoghi dove ho elaborato un po’ meglio le mie impressioni non esiterò a indirizzarvici per approfondire.
- no, Crossroads di Franzen non l’ho ancora finito. Abbiate pietà per i ritmi altrui.

Benone, ribadendo l’onnipresente problema della fallibilità umana, ecco qua il mio miglior 2021 libresco.
*

Bernardine Evaristo
Ragazza, donna, altro
(Sur)
Traduzione di Martina Testa
Un esperimento narrativo corale che sintetizza senza retorica o condiscendenza tanto del dibattito (finalmente) attuale su rappresentazione, genere, identità e privilegio. Un libro prezioso per innovazione strutturale, piglio bellicoso e per rifocalizzazione del punto di vista.
Ecco qua dove ne avevo parlato in origine.
*

Elizabeth Strout
Olive, ancora lei
(Einaudi)
Traduzione di Susanna Basso
Il ritorno di Olive Kitteridge, la bisbetica più amata del Maine, ha rinnovato la mia ammirazione per Elizabeth Strout, che si conferma splendida ritrattista delle minuzie del tran tran quotidiano e delle testarde meschinità con cui tendiamo a complicarci la vita. È anche un libro che indaga gli effetti del trascorrere del tempo e il coraggio necessario per concederci una seconda possibilità, per quanto tardiva e monca ci possa sembrare.
Serve un approfondimento? Accomodatevi qua.
*

Teresa Ciabatti
Sembrava bellezza
(Mondadori)
Cianciamo tanto della necessità di dipingerci “forti” e poco inclini a compromessi, ci dichiariamo pronte ad accogliere ogni genere di sensibilità – inclusi i personaggi femminili capaci di concedersi l’indubbio lusso di una spigolosità palese e impenitente – e applaudiamo senza remore i più vari elogi dell’imperfezione, ma quanto ci crediamo davvero? Quanto li digeriamo senza subirne con stizza l’urto inevitabile? Forse Teresa Ciabatti non è facile da leggere. Anzi, non è piacevole da leggere. Nella voce narrante che sceglie per Sembrava bellezza non c’è nulla di comodo, edulcorato o strutturato per rassicurarci. Ecco, reduce da un biennio in cui il mondo sembra essersi accorto (con comodo) che anche il pensiero positivo perenne e onnipresente può risultare tossico e colpevolizzante, ho trovato questo romanzo particolarmente liberatorio. Ma non tanto per il gusto di seguire le peregrinazioni di una ragazza “cattiva” che mai metabolizza fino in fondo delle ombre dell’adolescenza, credo sia più una questione di zone grigie. Non c’è desiderio di rivalsa senza insoddisfazione e non c’è narratrice inaffidabilissima che non sia anche profondamente consapevole delle proprie storture e delle proprie mancanze. Non c’è ambizione all’ascesa – sia estetica che di “status” – che non parta da un’intima conoscenza di una distribuzione disomogenea delle fortune. Credo sia anche per questo che ho amato questo libro: è probabile che i personaggi imperfetti la sappiano più lunga di noi perché conoscono sia i loro deficit che quel che occorrerebbe per raggiungere la felicità e l’appagamento. Vivono all’interno di quella distanza impossibile da colmare e ci abitano concedendosi il loro unico guizzo sincero: un’insoddisfazione sacrosanta, velenosa, più vera di ogni tentativo di dipingersi meglio di quel che sono e, nel non sapersi vendicare in prima persona, vendicano noi.
Per una cronaca un po’ più lineare di questo libro, qua si può riguardare la diretta con la sottoscritta, Daniela Collu e – in coda – Teresa Ciabatti, che appare come un cigno-fantasma.
*

Kazuo Ishiguro
Klara e il sole
(Einaudi)
Traduzione di Susanna Basso
Ishiguro è stato uno dei graditi e attesi ritorni – non pochi, devo dire – del 2021. Anche a questo giro il tema al cuore del romanzo è il seguente: che cosa ci rende umani? Per ipotizzare una risposta, Ishiguro si fa aiutare da una schiera di simulacri – molto realistici e credibili, ma pur sempre artificiali – che popolano un mondo rarefatto e socialmente atomizzato. Si piange pure con gli androidi? Già.
Il post provvisto di tutti gli optional e degli upgrade più moderni si può leggere qua.
*

Giulia Caminito
L’acqua del lago non è mai dolce
(Bompiani)
Ho tifato tanto allo Strega – non è servito -, ma Giulia Caminito ha avuto la sua rivincita al Campiello e ne sono stata immensamente felice, di certo per il valore del romanzo ma anche per la soddisfazione di veder riconosciuto, per una volta, il talento di un’autrice limitrofa alla mia condizione anagrafica e che di sconfitte generazionali ha parlato senza piagnistei e deferenza verso l’ordine costituito. Gaia, la protagonista, è una piccola gorgone di lago e anche la lingua che Caminito sceglie per guidarci nella sua lotta quotidiana sconfina quasi nell’incisività e nel piglio del mito. Si parte da una famiglia disastrata, tenuta insieme solo dalla forza di volontà e dall’impermeabilità all’umiliazione dell’ingombrantissima madre, Antonia. Si procede per tappe, verso un riscatto imposto che passa per lo studio e le violentissime reazioni all’accumulo di ingiustizie di quegli anni che ci vengono spesso venduti come i più verdi e belli, ma sono verdi e belli quanto il fondo limaccioso e buio del lago di Bracciano, cornice di questa storia. Non ci si lamenta, non ci si rassegna, non si mostra il fianco. Ma dopo tutta questa fatica, tutta questa brace incandescente che coviamo e che man mano diventa sempre più fredda e rassegnata, dov’è tutto quello che ci è stato promesso? È forse mai esistito?
*

Leigh Bardugo
La trilogia di Shadow and Bone
La serie di Netflix, almeno nel mio caso, ha prodotto quell’auspicabile esternalità positiva che prevede la trasformazione dello spettatore televisivo in lettore del materiale di partenza. Di solito preferisco arrivare “preparata” alla visione di una serie, ma in casi più rari può anche capitare che ci si trasformi in salmoni che compiono all’inverso il naturale percorso di avvicinamento. I tre romanzi di Tenebre e ossa mi hanno egregiamente tenuto compagnia, generando anche quell’effetto “devo vedere subito come va a finire” che non si manifestava da un po’. Per quanto trovi Alina irritantissima e per quanto io sia perfettamente in grado di scorgere più di un difetto nell’impianto generale e nella “resa” di questi libri, non è stato affatto impervio sedermi là a godermeli lo stesso. Innumerevoli sono stati gli incoraggiamenti a proseguire con Sei di corvi – se non proprio i “lascia perdere i primi tre, puoi leggere direttamente la duologia che è molto meglio”, ma m’è sembrato più opportuno farmi un’idea meno raffazzonata del mondo e dunque eccoci qua con un timbro nuovo di pacca sul passaporto del Grishaverse. Grazie per aver fornito il necessario intrattenimento, Leigh Bardugo. E un saluto anche a te, Ben Barnes.
*

Emmanuel Carrère
Yoga
(Adelphi)
Traduzione di Lorenza Di Lella e Francesca Scala
Che anno denso di attesi ritorni (non deludenti) e di narratori splendidamente inaffidabili, è il caso di dirlo. Carrère continua a menarci per il naso? È possibile, ma a questa ipotetica grande mistificazione – che forse poi è la mistificazione strutturale che passa per la soggettività del ricordo e di quello che ci raccontiamo per sopportare quello che succede, forse – continuo a cedere volentieri.
Per impressioni un po’ meno nebulose, il post era qui.
*

A cura di Sheila Williams
Relazioni – Amanti, amici e famiglie del futuro
(451)
Dodici racconti – raccolti da Sheila Williams per l’annuale impresa antologica della longeva serie tematica Twelve Tomorrows del MIT – per ipotizzare altrettante nuove strutture dello “stare insieme” in un contesto più o meno dominato dalla tecnologia. Coppia, figli, dating, eredità e memoria… cosa ci riserverà il futuro nel vasto calderone del legame sentimentale, dell’ordine sociale e della relazione umana? Grandi nomi della speculative fiction e della fantascienza cercano di immaginare una risposta – e no, non è detto che sia catastrofica.
Per approfondire, ecco qua.
*

Anna Maria Ortese
Il mare non bagna Napoli
(Adelphi)
Qua c’è un racconto che chissà in quale maniera sconclusionata avevamo letto a scuola. È il racconto della bambina che non ci vede e finalmente riceve un paio d’occhiali, per poi scoprire che tutto sommato stava meglio prima, in una realtà ovattata e nebulosa che le risparmiava l’orrore di una messa a fuoco precisa dell’esistente. E quel che esiste attorno a lei è Napoli, una vertigine urbana che sobbolle e digerisce a ciclo continuo ogni possibile configurazione dell’umano. Non rammento una lezione su Anna Maria Ortese, a scuola, ma il racconto della bambina mezza orba sì. Gli altri quattro movimenti di questa sinfonia dissonante e magnifica sono un tardivo recupero e, credo, anche una prova di coraggio – non tanto per me che leggo, ma più per Ortese che scrive senza pentimenti. Il tempo per pentirsi e limare sarebbe poi arrivato, ma quel che resta è una capacità magnetica di creare una distanza, il distacco necessario ad esercitare la libertà dello sguardo, a inforcare quegli stramaledetti occhiali per esercitare una soggettività unica, inclemente, poetica, mostruosa e viva.
*

Madeline Miller
Circe
(Marsilio)
Traduzione di Marinella Magrì
No, non so ancora dirvi nulla sulla Canzone di Achille. Dopo aver così apprezzato Circe, però, sono certa che lo affronterò presto e con una certa fiducia. Figlia del Sole e della ninfa Perseide, Circe cresce fra i Titani imparando a schivare le folgori delle nuove divinità olimpiche. Da sempre poco malleabile e incomparabilmente meno luminosa dei suoi fratelli, compatisce Prometeo e crea mostri, cercando un luogo dove potersi sentire davvero a casa. Paradossalmente, la vita di Circe sembra germogliare davvero da quella che per dei e mortali potrebbe somigliare alla peggiore delle condanne: l’esilio eterno sull’isola di Eea. Tra animali e piante, Circe asseconda la magia e diventa il cuore pulsante di un universo di prodigi, incontri, lotte secolari e sorti illustri. Una rivisitazione godibilissima e colta che espande il mito e trasforma in protagonista indimenticabile una figura in cui siamo abituati a imbatterci quasi di sfuggita: la comparsa infida ed egoista nella grande epopea dell’astuto e nobile Odisseo assume qui rotondità, mente, cuore e potere. Non solo equipaggi trasformati in maiali, insomma, ma una maga che pur andando ben poco a spasso contiene moltitudini. Viva Circe. E occhio a Scilla.
*

Paolo Cognetti
La felicità del lupo
(Einaudi)
Allora, io a Fontana Fredda non ci vivrei in pianta stabile, ma mi fa piacere soggiornarci per qualche tempo per andare a trovare i personaggi di Cognetti. Forse no, non ho ancora finito la mia decrescita cittadina e non sono ancora pronta a confrontarmi con l’immensità glaciale delle vette montane, ma anche questa volta il sortilegio d’alta quota si è ripetuto. È un romanzo che rallenta il ritmo del quotidiano e lascia intravedere un’alternativa che ha poco della negazione e del rifiuto e molto della ricostruzione ragionata. Pur restando dove sono, è un libro che mi ha fatto bene.
Per qualche impressione un po’ più articolata, vi indirizzo volentieri qui.
*
Concluderei con un ringraziamento un po’ ridicolo. Vorrei ringraziare i libri che sono riuscita a leggere quest’anno – pure quelli brutti o deludenti – per avermi accompagnata per un pezzo di strada. Neanche il 2021 è stato un anno semplice o particolarmente ricco di speranze provenienti dal mondo esterno e poter costruire, leggendo, un rifugio o un’oasi di sano svago ha rappresentato per me un buon punto fermo. Pochi o tanti che siano, i libri che ho letto o ascoltato – e qua nei preferiti ce ne sono diversi che ho ascoltato, da Circe a Il mare non bagna Napoli, ma anche Giulia Caminito – sono stati un puntello e un posto diverso dove far lavorare il cervello. Pochi o tanti che siano, è andata bene così.
Ulteriori rotte per la navigazione:
– siete in ritardo coi regali ma volete fare dei regali “letterari”? Vi lascio un memo per Storytel. Ci sono un casino di gift card e qua c’è sempre il mese gratis che vi donano perché siamo amici.
– a parte Instagram, anche qua nella vetrina Amazon cerco sempre di tenere traccia di quello che leggo man mano.
– la lista di Natale “generale”.
– la lista di Natale per i piccoli e le piccole.
 Ecco, Bignardi rompe (non senza allegria) il solido nesso causale, forse inconscio e sicuramente assai condivisibile, tra libro triste e libro che t’azzoppa o ti segna eternamente. Ci fa l’immensa cortesia di complicare le cose, di esplorare l’intersezione che si crea tra chi siamo in un determinato momento nel tempo e cosa leggiamo in quel momento nel tempo. Ci ricorda che molto spesso sono gli incontri accidentali – con un libro pescato per caso e senza programmaticità dallo scaffale di una sorella, ad esempio – a contenere un vasto potenziale rivelatorio. Ci sono romanzi che diventano destino, che scatenano quel riconoscimento che non sta solo nello scovare un personaggio a cui più o meno stanno capitando le nostre stesse brutture o gioie. Riconoscersi aiuta a partecipare? Penso di sì, ma anche quello dipende da chi siamo quando leggiamo. A rovinarci la vita può essere anche un romanzo che ci mostra un’allegria che sentiamo di non poter sprigionare o un personaggio che riesce a fare tutto quello che a noi costa una fatica strutturale. Ci rovinano la vita sia i legami spezzati che i cerchi che si chiudono fin troppo bene, la gente interessante e misteriosa che ci ricorda la nostra scarsa originalità, chi parte in smaccato vantaggio o chi ci fa venire il nervoso perché gliene capitano troppe. Quel che ci fa male non ci fa male in uno spazio vuoto, atterra col suo bagaglio di potenziali conseguenze in un territorio che possiede già un suo paesaggio di baratri terrificanti, radure idilliache e torrentelli vivaci. E come cambiano i paesaggi, nel corso del tempo cambiamo anche noi. Libri che mi hanno rovinato la vita, rende giustizia a questo processo di erosione e rinnovamento, collocando quel che leggiamo nel nostro tempo. È un po’ come sfogliare un album di ricordi, riconoscendo chi eravamo alla luce di quel che sappiamo oggi, facendoci aiutare dai libri che per una ragione o per l’altra sono stati rilevanti – e spesso motore di ripensamento, ombra e ferite.
Ecco, Bignardi rompe (non senza allegria) il solido nesso causale, forse inconscio e sicuramente assai condivisibile, tra libro triste e libro che t’azzoppa o ti segna eternamente. Ci fa l’immensa cortesia di complicare le cose, di esplorare l’intersezione che si crea tra chi siamo in un determinato momento nel tempo e cosa leggiamo in quel momento nel tempo. Ci ricorda che molto spesso sono gli incontri accidentali – con un libro pescato per caso e senza programmaticità dallo scaffale di una sorella, ad esempio – a contenere un vasto potenziale rivelatorio. Ci sono romanzi che diventano destino, che scatenano quel riconoscimento che non sta solo nello scovare un personaggio a cui più o meno stanno capitando le nostre stesse brutture o gioie. Riconoscersi aiuta a partecipare? Penso di sì, ma anche quello dipende da chi siamo quando leggiamo. A rovinarci la vita può essere anche un romanzo che ci mostra un’allegria che sentiamo di non poter sprigionare o un personaggio che riesce a fare tutto quello che a noi costa una fatica strutturale. Ci rovinano la vita sia i legami spezzati che i cerchi che si chiudono fin troppo bene, la gente interessante e misteriosa che ci ricorda la nostra scarsa originalità, chi parte in smaccato vantaggio o chi ci fa venire il nervoso perché gliene capitano troppe. Quel che ci fa male non ci fa male in uno spazio vuoto, atterra col suo bagaglio di potenziali conseguenze in un territorio che possiede già un suo paesaggio di baratri terrificanti, radure idilliache e torrentelli vivaci. E come cambiano i paesaggi, nel corso del tempo cambiamo anche noi. Libri che mi hanno rovinato la vita, rende giustizia a questo processo di erosione e rinnovamento, collocando quel che leggiamo nel nostro tempo. È un po’ come sfogliare un album di ricordi, riconoscendo chi eravamo alla luce di quel che sappiamo oggi, facendoci aiutare dai libri che per una ragione o per l’altra sono stati rilevanti – e spesso motore di ripensamento, ombra e ferite.


 Vi ho quasi certamente attaccato una pippa superflua, però.
Vi ho quasi certamente attaccato una pippa superflua, però. 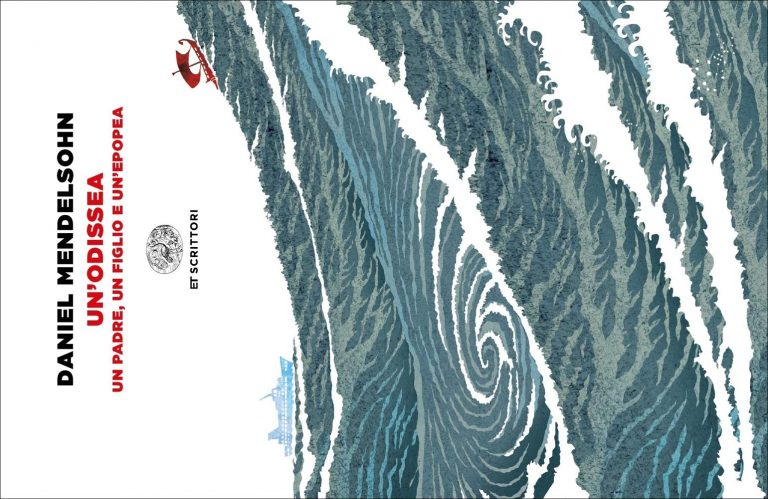
 Da dove si parte, con
Da dove si parte, con 
 Dunque, c’è una tecnica narrativa che nella sua rassicurante tondeggianza ci assiste sin dai tempi dell’Odissea: il racconto “ad anello”. Una vicenda si apre e, prima o poi, il cerchio si chiude, presentandoci una storia nella sua totalità senza tralasciare antefatti, peripezie mediane e conseguenze.
Dunque, c’è una tecnica narrativa che nella sua rassicurante tondeggianza ci assiste sin dai tempi dell’Odissea: il racconto “ad anello”. Una vicenda si apre e, prima o poi, il cerchio si chiude, presentandoci una storia nella sua totalità senza tralasciare antefatti, peripezie mediane e conseguenze.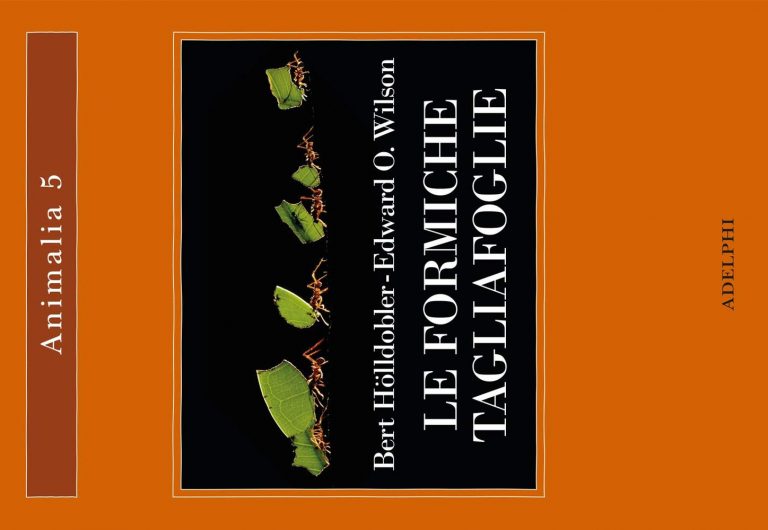

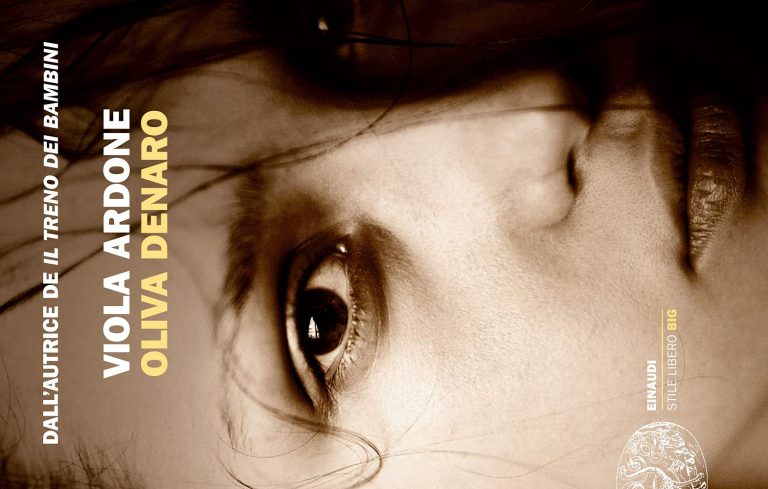
 Come parecchie lettrici e lettori, ho fatto amicizia con Viola Ardone grazie al
Come parecchie lettrici e lettori, ho fatto amicizia con Viola Ardone grazie al 















 Jean-François Champollion diventerà il vostro nuovo spauracchio durante quei tremendi momenti di smarrimento del tipo “maledizione, non ho ancora combinato niente nella vita… e ormai è tardi!”. Ebbene, Champollion decifrò la Stele di Rosetta a 20 anni, devastando la nostra autostima ma consegnando al contempo al mondo, nel 1822, la chiave per restituire voce ai monumenti di una civiltà intera, rimasti muti per millenni insieme al resto dell’abbondantissimo lascito documentario disseminato tra Alto e Basso Nilo. Io, a 20 anni, non riuscivo neanche a gestire un paio di collant, figuriamoci interpolare il greco, il demotico e i geroglifici, primeggiando tra gli studiosi della mia epoca in rapidità ed efficacia.
Jean-François Champollion diventerà il vostro nuovo spauracchio durante quei tremendi momenti di smarrimento del tipo “maledizione, non ho ancora combinato niente nella vita… e ormai è tardi!”. Ebbene, Champollion decifrò la Stele di Rosetta a 20 anni, devastando la nostra autostima ma consegnando al contempo al mondo, nel 1822, la chiave per restituire voce ai monumenti di una civiltà intera, rimasti muti per millenni insieme al resto dell’abbondantissimo lascito documentario disseminato tra Alto e Basso Nilo. Io, a 20 anni, non riuscivo neanche a gestire un paio di collant, figuriamoci interpolare il greco, il demotico e i geroglifici, primeggiando tra gli studiosi della mia epoca in rapidità ed efficacia.
 Il corpo che si trasforma (per dare la vita, ad esempio) o per affacciarsi alla sessualità è il grande campo di battaglia. La posta in gioco, argomenta Doyle, è quella del controllo da esercitare e preservare per fare in modo che lo status quo – l’impalcatura patriarcale pervasiva che ha strutturato da ambo le parti il nostro modo di concepire l’ordine umano del mondo – continui a reggere. E perché regga è necessario che i ruoli non cambino e che nessuna desideri più di quanto le è stato concesso. Chi devia dal seminato è mostro, strega, forza maligna, matta o belva.
Il corpo che si trasforma (per dare la vita, ad esempio) o per affacciarsi alla sessualità è il grande campo di battaglia. La posta in gioco, argomenta Doyle, è quella del controllo da esercitare e preservare per fare in modo che lo status quo – l’impalcatura patriarcale pervasiva che ha strutturato da ambo le parti il nostro modo di concepire l’ordine umano del mondo – continui a reggere. E perché regga è necessario che i ruoli non cambino e che nessuna desideri più di quanto le è stato concesso. Chi devia dal seminato è mostro, strega, forza maligna, matta o belva.