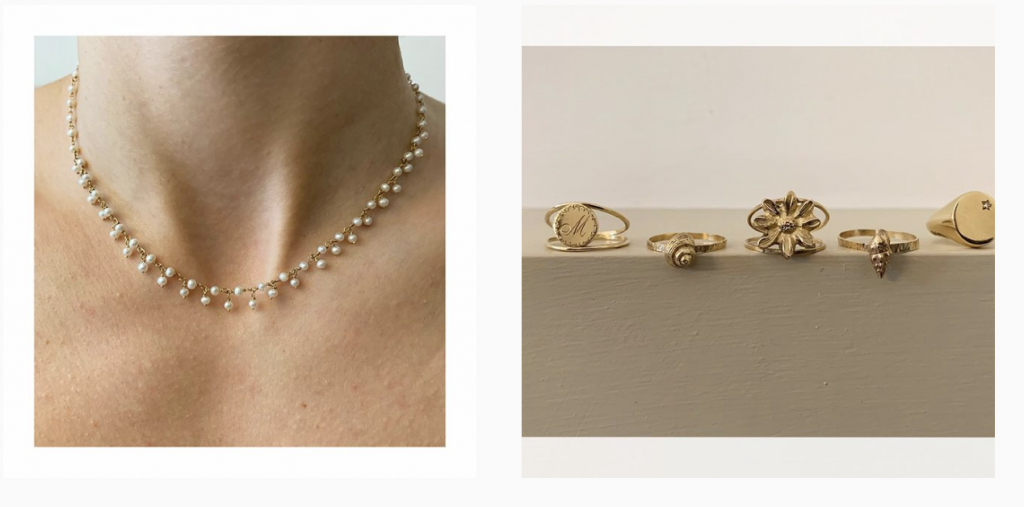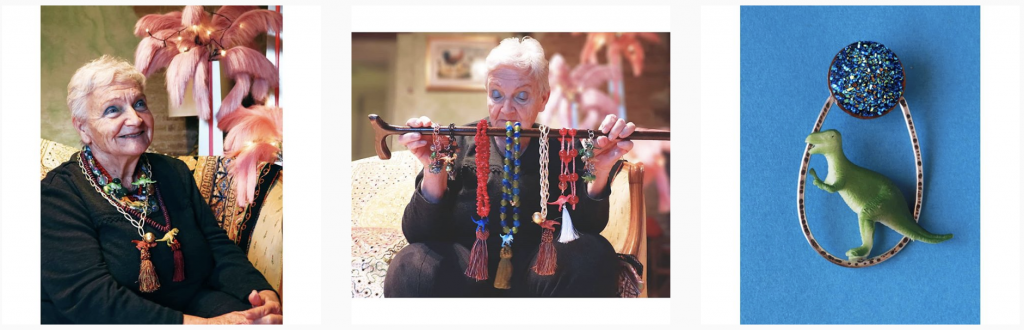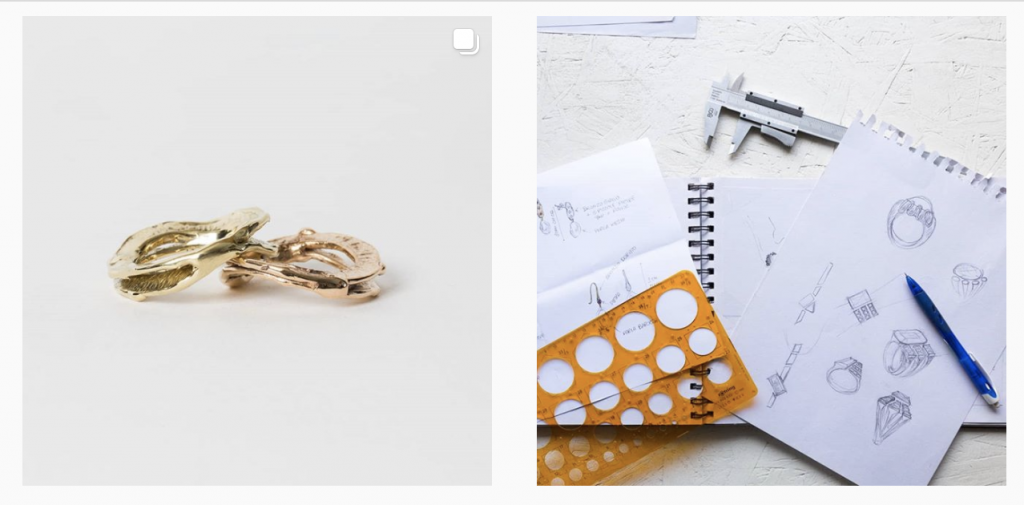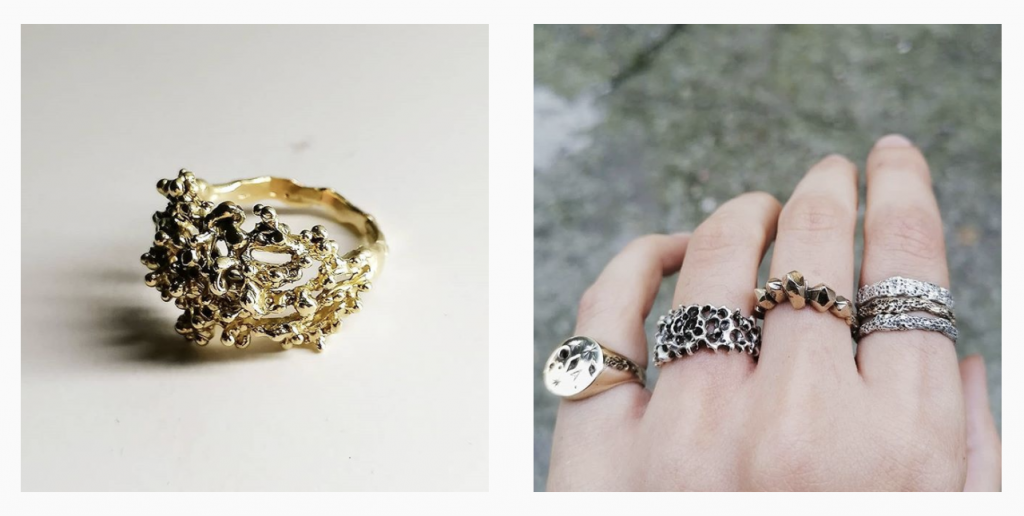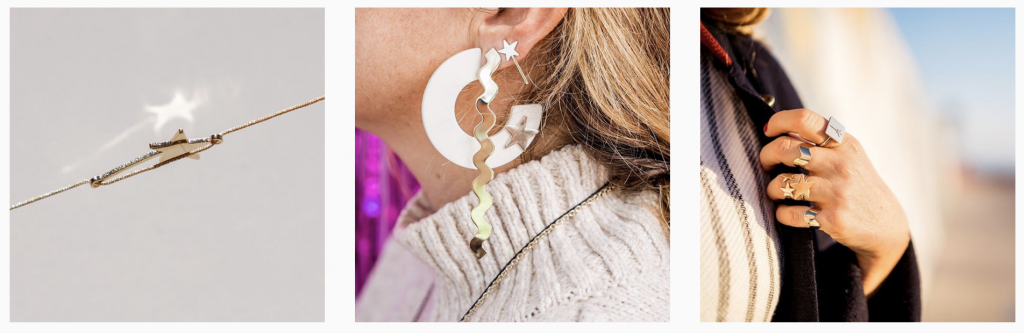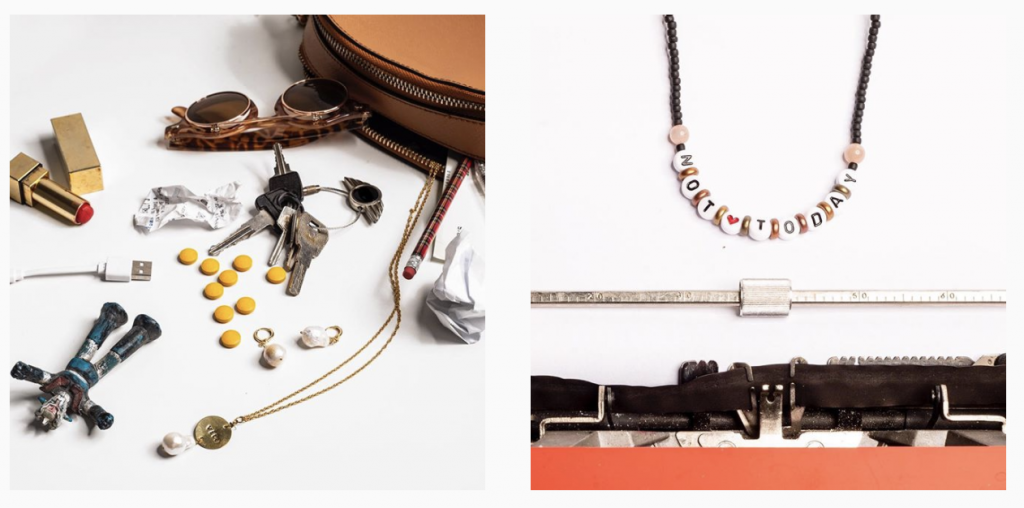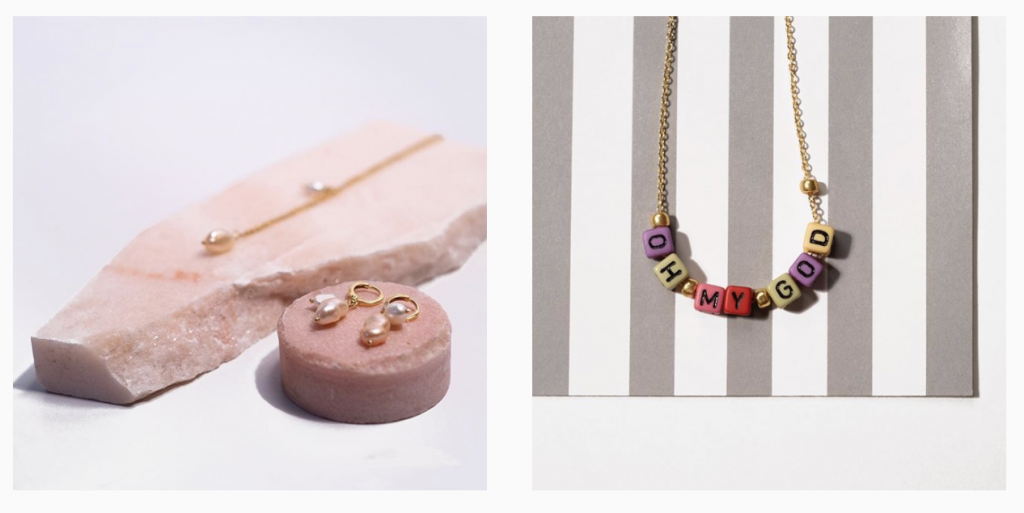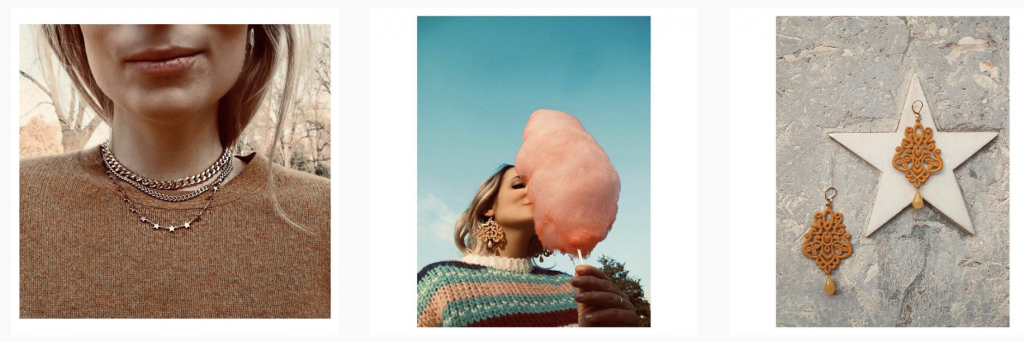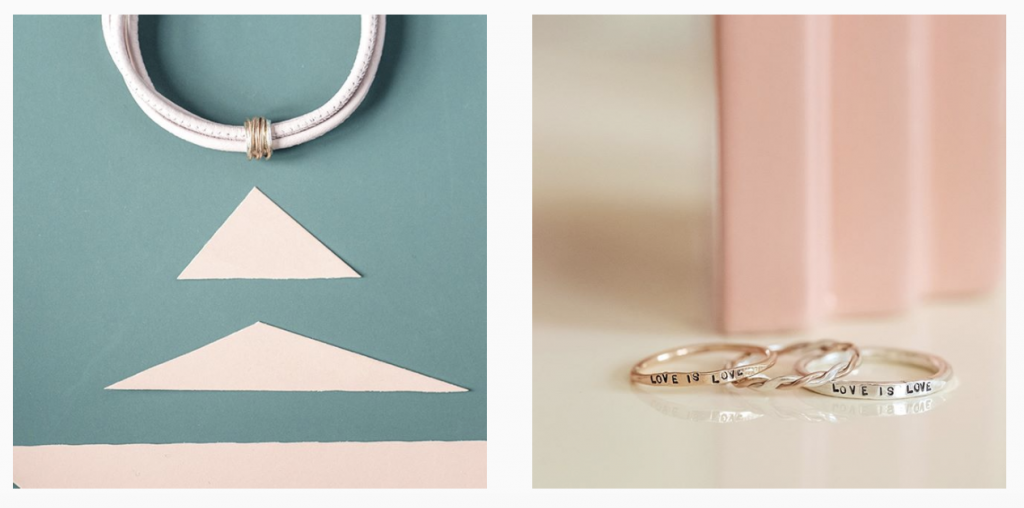Ma se questa è la lista BIS, vuol dire che ce n’era già un’altra?
Esatto. La trovate qua.
E benvenuti all’expansion-pack per riempire le vostre sportine – regolarmente di tela e recanti messaggi arguti – con qualche tascabile Einaudi uscito più di recente o sfuggito alle maglie sempre approssimative della mia memoria. L’intento, qua come nella lista precedente, non è quello di compilare l’elenco dei classici che non possono mancare nella vostra libreria – chi sono, Umberto Eco? – ma di frugare qua e là per segnalarvi avventure letterarie eterogenee che per me si sono rivelate preziose. Ho scoperto che quest’anno in sconto non vanno (per legge, pare) le novità dell’ultimo semestre, ma con l’idea di rendere questo post una risorsa duratura, segnalo comunque.
Procedo con sintetica efficienza. O almeno ci provo.
*

Da dove parto, se voglio leggere “qualcosa di femminista”? Le risposte possono essere numerose, ma di certo Adichie è un buon trampolino. Dovremmo essere tutti femministi è sempre gagliardamente disponibile nelle Vele in versione integrale, ma c’è anche questa edizione condensata, illustrata da Bianca Bagnarelli e pensata – se vogliamo dar retta alla bandella – per un pubblico di giovani virgulte e virgulti.
Sempre all’interno di questo filone, negli ET trovate anche Cara Ijeawele.
*

Dunque, il titolo dice Portatile, ma sono comunque 800 pagine. Non credo bastino in ogni caso a contenere David Foster Wallace, ma è un’antologia che nasce con l’ambizione di pescare quello che di più emblematico, “riconoscibile” e accessibile si possa leggere di suo, per avvicinarsi a quello che ha prodotto riducendo il comprensibile disorientamento che potrebbe assalirci. Ci sono stralci estrapolati dai suoi romanzi, interventi di saggistica, racconti e materiale più didattico.
*

In attesa di leggere il romanzo nuovo – che dovrebbe uscire in autunno in inglese, se non ricordo male o se non sono troppo ottimista – negli ET Scrittori sono già approdati entrambi i suoi libri, Parlarne tra amici e Persone normali.
Vi rimando al post su Persone normali, che fra i due resta il mio preferito.
*

Dopo Le otto montagne sono ormai diventata una fedele fruitrice del Cognetti montanaro. Se Cognetti va in montagna io sono contenta, serena, pacificata. Qua, insieme a una nutrita schiera di guide e con due cari amici (più lo spettro dell’inafferrabile leopardo delle nevi, svariati asini e un blocco da disegno), decide di celebrare il traguardo dei quarant’anni facendosi 300 km a piedi per il Tibet himalayano. Tiè.
*

Non di solo Murakami si anima il Giappone libresco, ma anche dei tormenti dei personaggi di Kawabata – che s’è meritato anche un Nobel -, in bilico tra i codici sublimi dell’arte e il torbido delle passioni silenziose. Per approfondire, anche se abita nelle Letture, ci sono anche i racconti di Prima neve sul Fuji.
*

Visto che ci siamo addentrati in territorio giapponese, chiamerei in causa anche Kazuo Ishiguro, che però non è solito ambientare lì le sue storie. Un artista del mondo fluttuante è un’eccezione, è il suo “romanzo giapponese”. Il protagonista è un anziano e illustre pittore che, al termine della Seconda Guerra Mondiale, si vede progressivamente ostracizzato per il suo dichiarato e duraturo appoggio al regime imperialista.
Per Ishigurare ulteriormente vi rammento – a costo di ripetermi – anche Quel che resta del giorno, Il gigante sepolto, Un pallido orizzonte di colline e Non lasciarmi.
*

Exit West credo sia l’unico romanzo che in questi anni mi sono sentita di etichettare – dall’alto della mia VASTA autorità, proprio – come necessario. “Necessario” è diventata la nuova formula magica per praticamente tutto, è un po’ il nuovo “un saggio che si legge come un romanzo”. Ecco, in questo caso è vero. È una storia d’amore e una storia di migrazioni, ma è sopra ogni altra cosa una storia che parla di esseri umani. Utilizza un espediente “fantastico” – quello delle porte che si aprono su luoghi lontani – per analizzare cosa succede nei cuori dei singoli e alle società in senso più ampio quando si scappa da casa propria per trovare salvezza da un’altra parte.
*

Per quanto il personaggio di Elizabeth Strout più amato dalla collettività resti con ogni probabilità Olive Kitteridge, anche in Mi chiamo Lucy Barton ritroviamo quell’attenzione minuta ai moti dell’animo e quell’infilata emblematica di piccoli eventi quotidiani che messi tutti in fila tracciano la traiettoria di una vita. Qui abbiamo una madre e una figlia che si ritrovano dopo una voragine che si è spalancata tra loro. Cinque giorni e cinque notti di ricordi e rivelazioni finalmente “vere” in una stanza d’ospedale a Manhattan.
*

Il mio è stato un recupero tardivo di Natalia Ginzburg. Ho riletto Lessico famigliare un paio d’anni fa – dopo averlo poco capito al liceo – e ci ho trovato dentro un tesoro a cui continuo ad aggiungere lingotti luccicanti man mano che proseguo con le sue raccolte di saggi brevi, articoli e chiacchiere – come Mai devi domandarmi – o con i suoi romanzi. Quello che mi rallegra molto è che per completare l’opera mi restano ancora un po’ di Natalie ancora da conoscere.
*

Più che una raccolta di “reportage”, L’Italia spensierata è un’indagine sociologica sulle tappe obbligate dell’italiano-tipo. C’è Piccolo che visita scientificamente un Autogrill, che porta delle bambine a un parco di divertimenti, che va “a fare il pubblico” a Domenica In… Riti collettivi, sviscerati con arguzia, ai quali abbiamo giurato e spergiurato di non partecipare mai, anche se ci siamo già dentro con tutte le scarpe.
*

Il figlio parte come un romanzo sulla Frontiera e si trasforma in una saga generazionale fatta di ideali traditi, ribellioni, compromessi sanguinosi, petrolio e macchie indelebili. Dai Comanche – che rapiscono il patriarca in tenera età – ai pozzi petroliferi del Texas Occidentale, Meyer ci consegna una galleria di personaggi risoluti e imperfetti, ma anche una porzione vividissima di storia americana.
*
Saluti, cuorosità e buone letture. :3





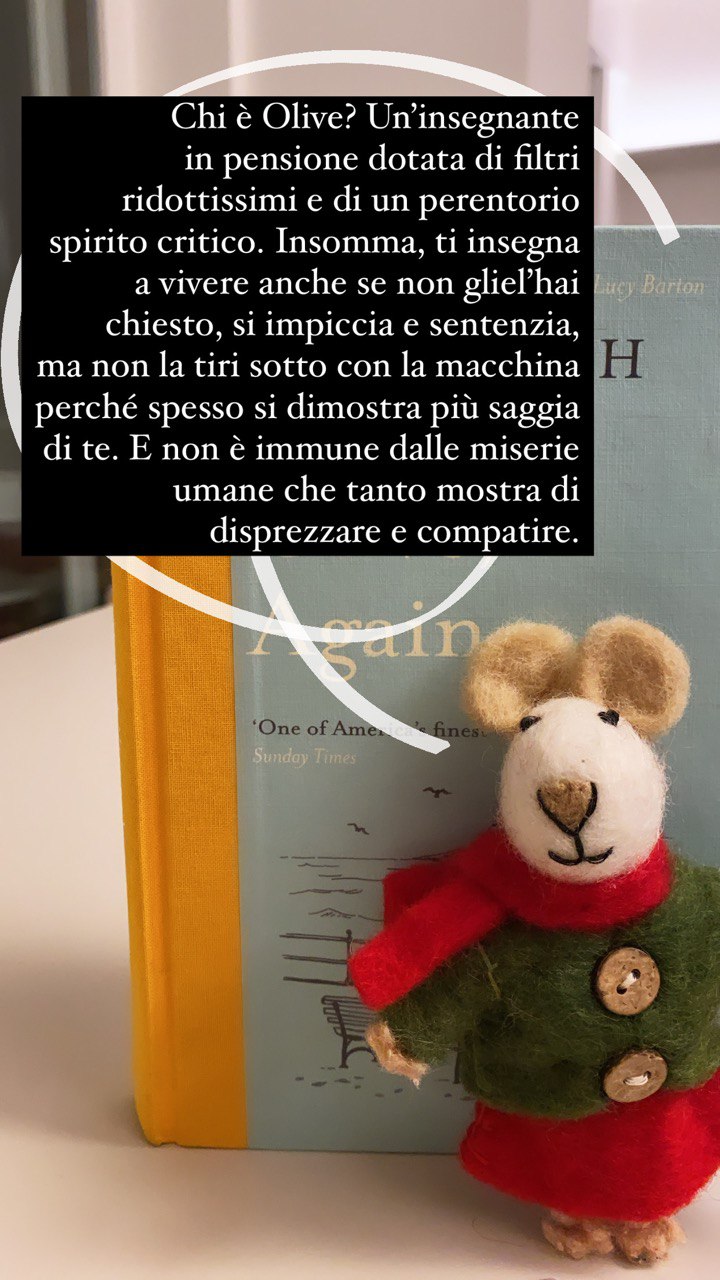
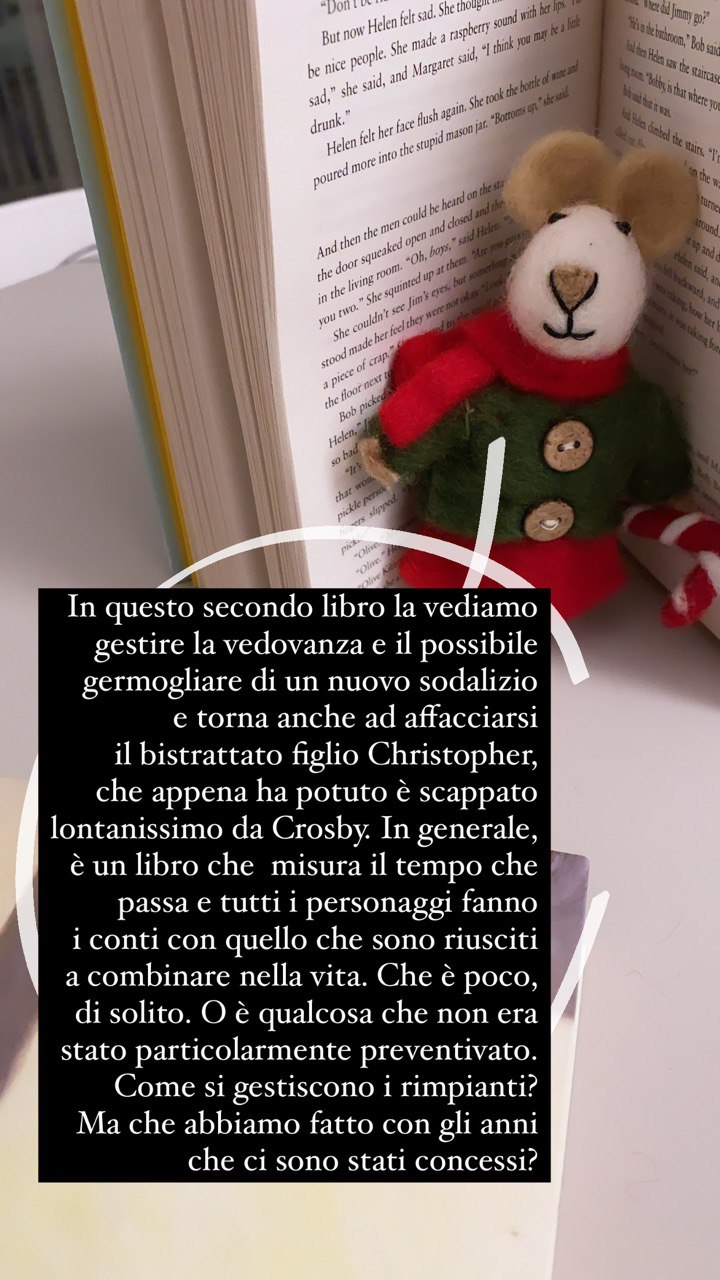
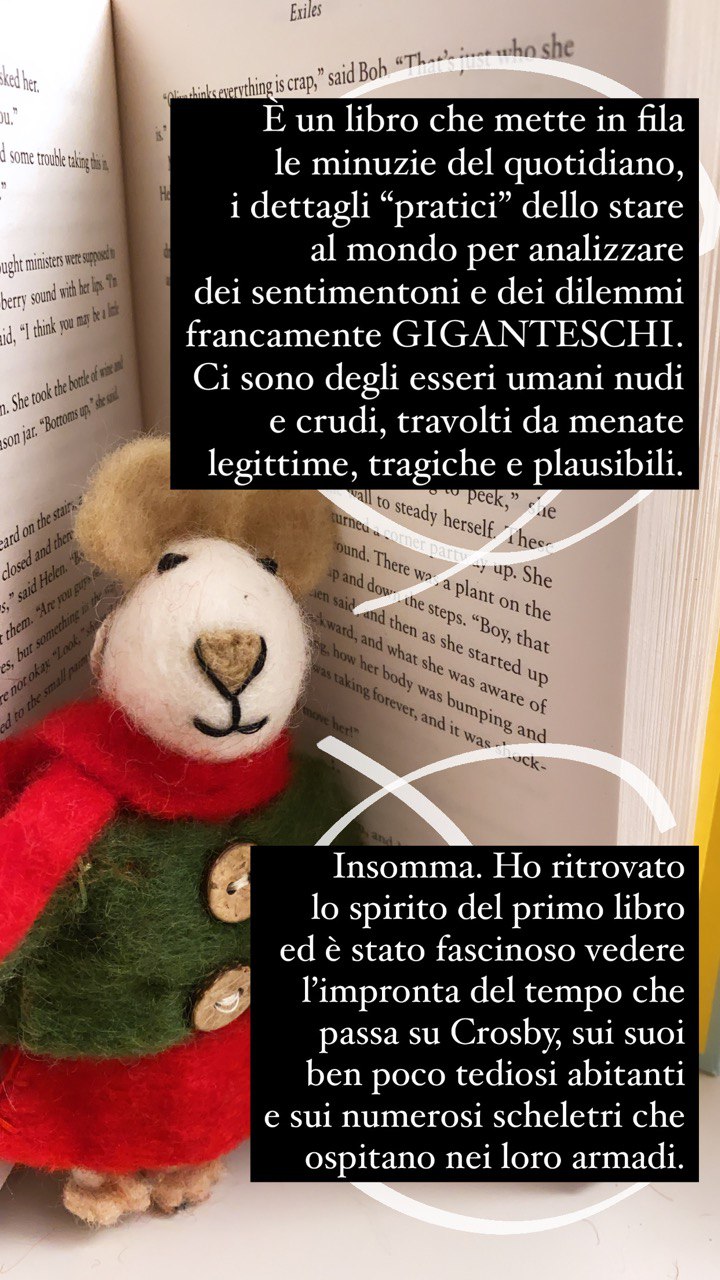
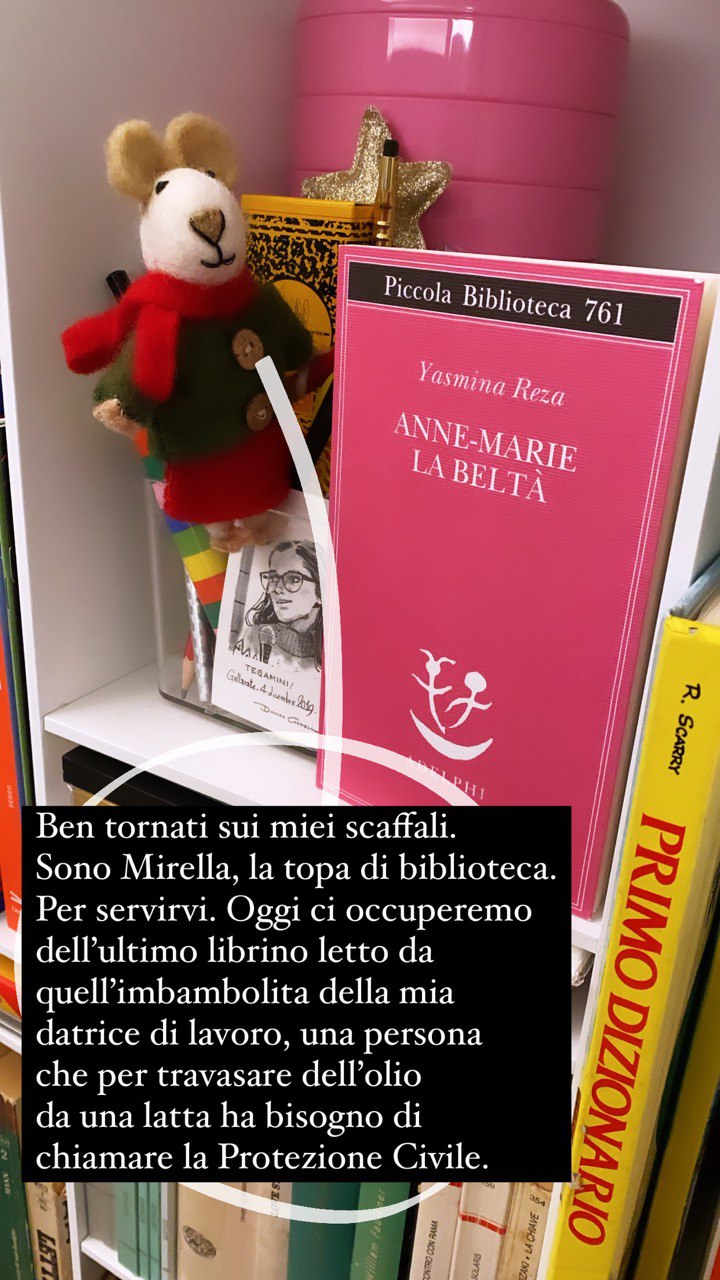
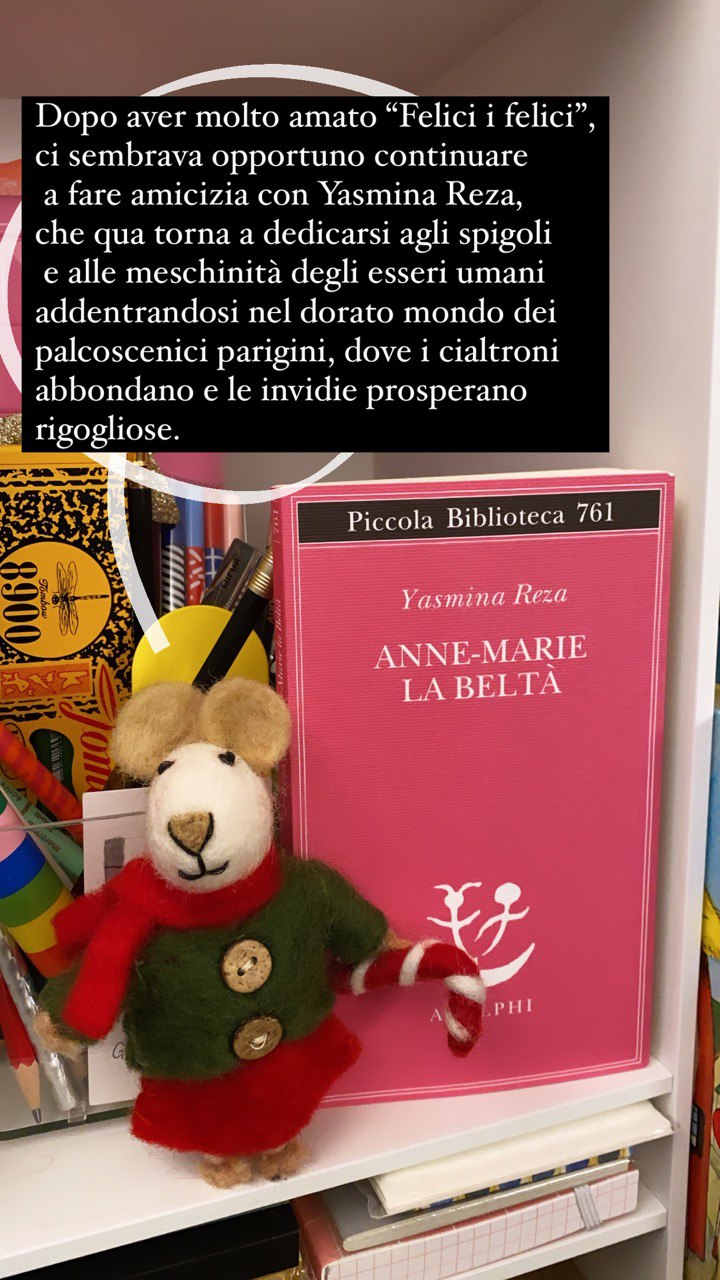
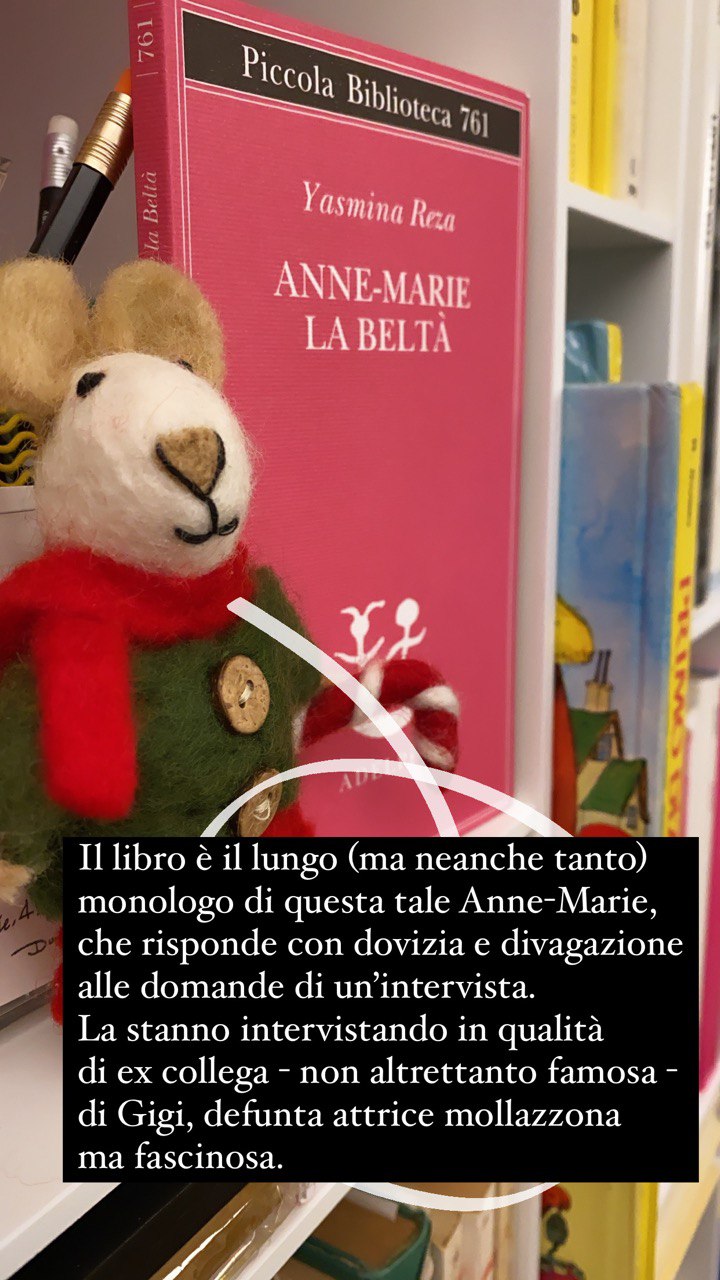
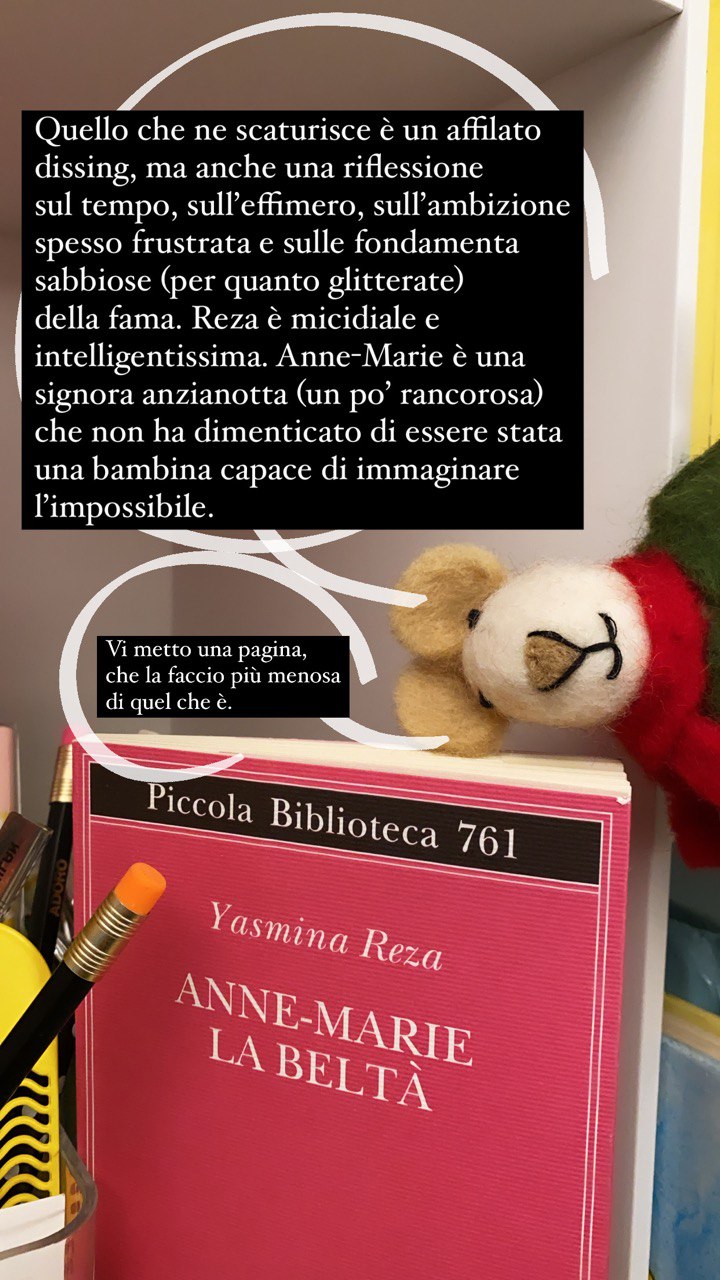



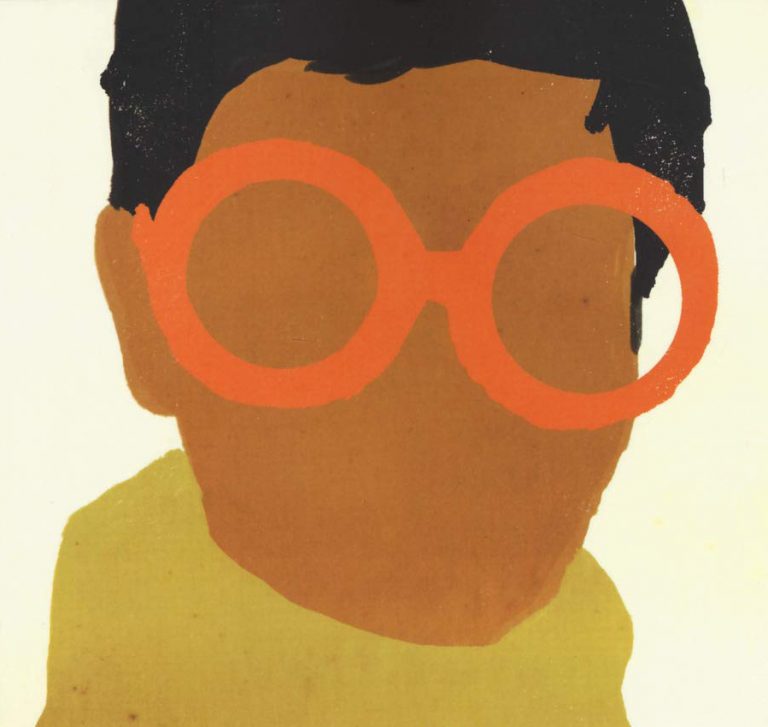
 Tutto parte da Amma, bastian contraria della scena teatrale londinese – femminista militante, nera, lesbica – che si prepara a debuttare con il primo spettacolo della sua carriera che sia mai davvero riuscito ad approdare al mainstream. Attorno a lei, più o meno direttamente, si aggrovigliano e si srotolano nel tempo le esperienze delle altre undici staffettiste. Ciascun personaggio corre la sua frazione del percorso tenendo ben alta una fiaccola che illuminerà per noi una fetta diversa di quell'”alterità” che Evaristo vuole finalmente portare al centro del discorso. Per quanto questo obiettivo strutturale ci risulti evidente – e per quanto qualche passaggio sia più didascalico di altri -, sono donne che galoppano veloci e sicure, lasciandosi alle spalle il rischio di risultare artificiose. Metafore podistiche a parte, il cuore del libro è proprio in quest’alternanza di contesti, prese di posizione, sfumature, epoche e provenienze. È un romanzo ricco perché ricco è lo spettro di possibilità che ospita.
Tutto parte da Amma, bastian contraria della scena teatrale londinese – femminista militante, nera, lesbica – che si prepara a debuttare con il primo spettacolo della sua carriera che sia mai davvero riuscito ad approdare al mainstream. Attorno a lei, più o meno direttamente, si aggrovigliano e si srotolano nel tempo le esperienze delle altre undici staffettiste. Ciascun personaggio corre la sua frazione del percorso tenendo ben alta una fiaccola che illuminerà per noi una fetta diversa di quell'”alterità” che Evaristo vuole finalmente portare al centro del discorso. Per quanto questo obiettivo strutturale ci risulti evidente – e per quanto qualche passaggio sia più didascalico di altri -, sono donne che galoppano veloci e sicure, lasciandosi alle spalle il rischio di risultare artificiose. Metafore podistiche a parte, il cuore del libro è proprio in quest’alternanza di contesti, prese di posizione, sfumature, epoche e provenienze. È un romanzo ricco perché ricco è lo spettro di possibilità che ospita.








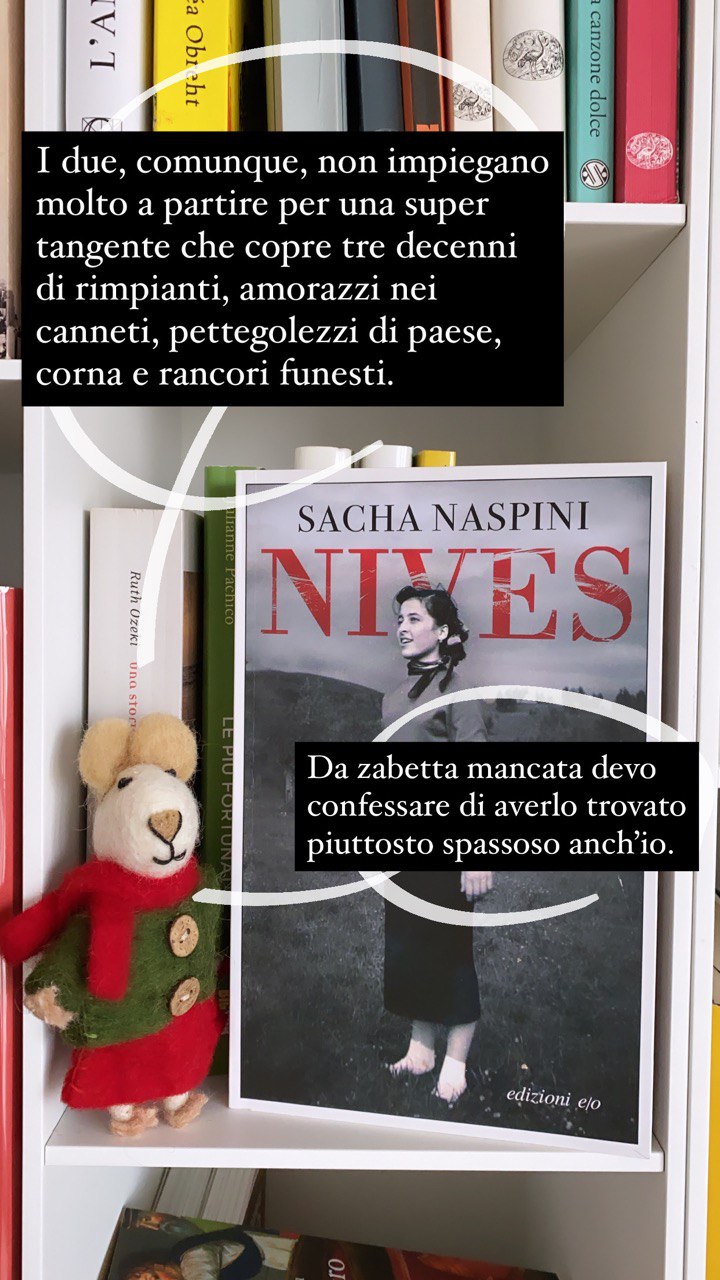
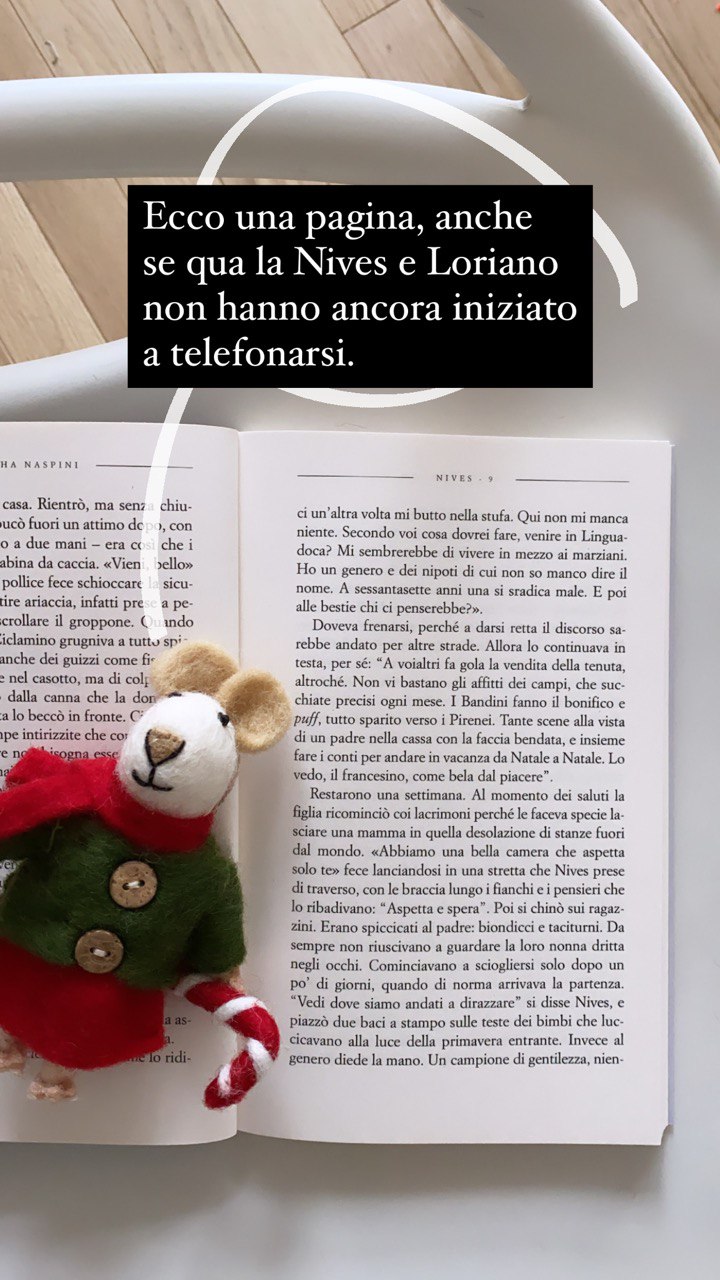
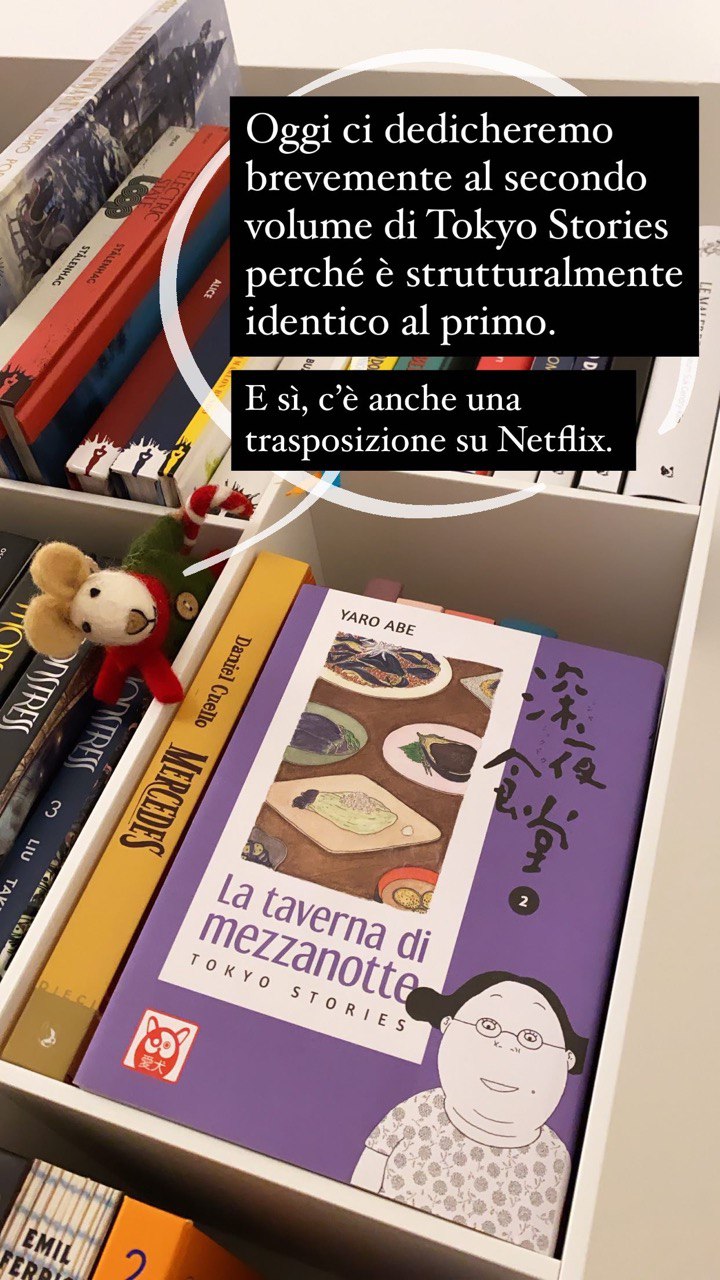






![Città sola (La cultura Vol. 1152) di [Olivia Laing, Francesca Mastruzzo]](https://m.media-amazon.com/images/I/51mGA3HRsJL.jpg)



























![Dimmi cosa leggi e ti dirò chi sei di [Grant Snider, Boris Battaglia]](https://m.media-amazon.com/images/I/51tUw1JMNqL.jpg)