Forse salterà fuori che il nostro unico e autentico pregio è stato quello di aver tenuto i piedi in due epoche, di aver visto arrivare un orizzonte nuovo e di essere stati testimoni di un cambiamento mastodontico, incomparabilmente più grande delle nostre capacità di governarlo o di renderlo un fattore di indubbio e generalizzato progresso. Custodiamo i nostri ricordi con la tenerezza ossessiva e un po’ stucchevole di chi ha lasciato perdere, di chi ha decretato che quel che poteva andare male è già andato male e che mai ci si imbatterà di nuovo in un tempo “facile”, relativamente più prospero e privo di responsabilità come l’infanzia. Quei ricordi ce li teniamo volentieri, insomma, a costo di fare la figura degli stupidi e dei piagnucoloni. Ogni generazione sarà la barzelletta di quella successiva, ma è possibile che la mia – quella dei Millennial – sia l’unica che tende ad accanirsi più volentieri su sé stessa che sulle compagini anagrafiche limitrofe. Abbiamo combattuto strenuamente per il ritorno del Winner Taco e, quando ce lo siamo finalmente potuto ricomprare, ci siamo accorti che era piccolissimo. Ecco, Doveva essere il nostro momento di Eleonora C. Caruso – in libreria per Mondadori – esplora quello spazio di delusione lì, quell’operazione sistematica di ridimensionamento delle aspettative che si scontra col “rimanerci male” lo stesso. Non possiamo farne a meno, perché barcolliamo da sempre su una sabbia mobile fatta di pupazzoni, benesseri promessi e perentori “sforzati, l’impegno verrà ripagato”. Ma quel che c’era a disposizione è rimasto dov’era e noi non abbiamo capito come prendercelo, come farci valere, come farci vedere. E ci incazziamo per il Winner Taco, perché incazzarci a livello “macro” è difficile, se alla coscienza collettiva siamo stati abituati a preferire rarissime punte di straordinarietà individuale che la realtà spazza puntualmente via.
 Caruso si appoggia alla struttura “classica” del viaggio per produrre un’avventura ideale che, qua e là, si trasforma con grande naturalezza in una specie di atlantone sociologico che riesce a tenere insieme il confronto generazionale, l’impatto del web su ogni sfera delle nostre relazioni e quella condizione di incertezza traballante e precaria – nel lavoro, nei sentimenti, nel legame con la famiglia d’origine, nella costruzione del futuro, nelle condizioni “materiali” di vita – che ha cessato di scomparire all’affacciarsi dell’età “adulta”. Caruso prende tutto questo magma ribollente di menate, maldestre rivendicazioni, riflessioni sul “ma che abbiamo che non va” e lo colloca in un luogo narrativo capace di trasformarlo in un impianto teorico dotato di coerenza interna, regole e principi. Insomma, fonda una “setta” e la usa come laboratorio.
Caruso si appoggia alla struttura “classica” del viaggio per produrre un’avventura ideale che, qua e là, si trasforma con grande naturalezza in una specie di atlantone sociologico che riesce a tenere insieme il confronto generazionale, l’impatto del web su ogni sfera delle nostre relazioni e quella condizione di incertezza traballante e precaria – nel lavoro, nei sentimenti, nel legame con la famiglia d’origine, nella costruzione del futuro, nelle condizioni “materiali” di vita – che ha cessato di scomparire all’affacciarsi dell’età “adulta”. Caruso prende tutto questo magma ribollente di menate, maldestre rivendicazioni, riflessioni sul “ma che abbiamo che non va” e lo colloca in un luogo narrativo capace di trasformarlo in un impianto teorico dotato di coerenza interna, regole e principi. Insomma, fonda una “setta” e la usa come laboratorio.
La setta romanzesca di Caruso dimora in un baglio – una masseria – in rovina nelle campagne del catanese. Ospita una gioventù (più o meno fresca) usurata dal mondo esterno e spremuta o ormai rifiutata dal mondi virtuali. È una capsula del tempo di raro potere evocativo, perché l’idea di base è che il mondo in cui valeva la pena soggiornare è finito nel 2001 e che tutto quello che è arrivato dopo sia maceria, rovina, tabù innominabile. Insomma, gli adepti di Zan – fondatore e responsabile dell’impresa – vivono negli anni Novanta. La moneta corrente delle comunità sono i ciucci di plastica, si guardano i Duck Tales in videocassetta, Cesare Cremonini sgasa sui colli bolognesi, i Tamagotchi pigolano con insistenza per essere nutriti e Pippo Baudo salva un aspirante suicida dalla balconata del teatro Ariston. Chi ha effettivamente vissuto gli anni Novanta è un Ritornato, chi mai ne ha fatto esperienza diretta è un Non Nato – e viene educato di conseguenza. Non sono ammessi smartphone, si comunica con l’esterno per lettera e non ci si connette a un bel niente.
La storia comincia quando Leo, trentaquattrenne che vive a Milano su un divano-letto in una casa che condivide con un numero imprecisato di coinquilini antipatici come la sabbia nelle mutande, parte alla volta della comunità di Zan per recuperare il suo amico Simone, che era andato a visitare quella sorta di utopia anni Novanta con l’intento di tirarci fuori un articolo succoso e auspicabilmente sarcastico. Ma passano i mesi e Simone non torna. Leo si presenta lì con l’intento di fermarsi giusto il tempo necessario a “salvare” il suo amico, ma anche lui finisce per trattenersi e per partecipare alla vita di quel microcosmo disancorato dal presente con un trasporto del tutto inaspettato.
Il libro si biforca qui – da una parte seguiremo quel che succede quando Leo fa effettivamente i bagagli e, dall’altra, scopriremo come è stato il suo soggiorno al baglio. Caruso dosa con grande abilità il racconto del viaggio verso nord e i flashback della “setta”, che si mescolano a tutto quello che è funzionale a farci conoscere meglio i personaggi. Simone un po’ ce lo possiamo dimenticare – è stato un utile pretesto -, perché il suo posto in macchina verrà occupato in maniera inattesa ma fatidica da Clorofrilla – o Cloro, per follower e conoscenti -, celeberrima youtuber dalla chioma rosa caduta quasi irrimediabilmente in disgrazia dopo un pionieristico passato da bambina prodigio. Cloro e Leo appartengono a due generazioni diverse, non si sono quasi mai parlati al baglio e hanno all’apparenza molto poco in comune, a parte un legame più “intenso” della media con Zan. Arriveranno indenni a Milano? Cosa scopriranno lungo la strada? Cosa scopriremo di noi durante il loro accidentato percorso?

Questo romanzo mi ha suscitato una calorosa ammirazione e spero verrà letto tanto e in tutte le sue matte stratificazioni. Lo si può leggere perché ci interessano gli ingarbugli fra i personaggi, lo si può leggere da incattiviti o da romantici, con l’occhio clinico di chi vuole capire il presente e con l’occhio pesto di chi pensa al presente con un disincanto che rasenta il disgusto. Mi sono sentita – a livello “anagrafico” – ritratta con una lucidità rara e trattata al contempo con una severità complessa e ben radicata in una visione consapevole. Diamine, Caruso sa di che parla e rivolta i nostri Pisoloni infeltriti – sempre che qualcuno ce l’abbia mai comprato PERCHÉ IO A SANTA LUCIA L’HO SEMPRE CHIESTO MA NON È ARRIVATO – per fotografare quel che resta di noi e cosa cerchiamo di mascherare con la nostalgia. Il riflesso che inseguiamo è molteplice, perché tantissime sono diventate le superfici riflettenti e le piazze di auto-rappresentazione in cui ci cimentiamo, sperando ci restituiscano rassicurazioni e validazione. È una storia che prova a riedificare i confini di tante identità prive di centro ma disperatamente in cerca di uno scopo, di una promessa in cui credere davvero, su cui ci sentiremo capaci di costruire finalmente qualcosa.
L’ho tirata in lungo, ma quel che vi serve sapere è che è proprio un bel libro e Caruso scrive come se Zan, Leo e Cloro fossero persone con cui ha appena finito di parlare al telefono. Di tatuaggi brutti, probabilmente. O di chi ha appena sbroccato su Instagram. O di quanto è diventato piccolo il Winner Taco, porca miseria.
 I genitori le hanno fornito una rete di salvataggio – le pagano l’affitto e, da misura temporanea in vista di un lavoro che l’avrebbe aiutata a stare in piedi da sola, è diventata una scorciatoia strutturale. Millie un po’ se ne vergogna e un po’ si rifiuta di pensarci e ogni ufficio in cui ricomincia da capo è una nuova speranza, che si tira dietro una lunga lista di nobili aspirazioni. Mangiare meglio, lavarsi di più, tenere in ordine, arredare con gusto, fare sport, leggere, bere meno, volersi bene. Ma è dura costruire un castello splendente quando le fondamenta traballano di continuo e Millie tira avanti rabbiosa, sfidando il tedio in una polarizzazione di desideri: vorrebbe un contratto “vero”, ma chi è che vorrebbe fare per sempre un lavoro così mesto? E che senso ha tirare a lucido una casa piena di cianfrusaglie da quattro soldi? Da un lato, Millie ha il lusso relativo di poter scegliere – e un minimo di spalle coperte – ma, dall’altro, le alternative a disposizione sono misere e di certo incompatibili con sogni di gloria e realizzazioni conclamate.
I genitori le hanno fornito una rete di salvataggio – le pagano l’affitto e, da misura temporanea in vista di un lavoro che l’avrebbe aiutata a stare in piedi da sola, è diventata una scorciatoia strutturale. Millie un po’ se ne vergogna e un po’ si rifiuta di pensarci e ogni ufficio in cui ricomincia da capo è una nuova speranza, che si tira dietro una lunga lista di nobili aspirazioni. Mangiare meglio, lavarsi di più, tenere in ordine, arredare con gusto, fare sport, leggere, bere meno, volersi bene. Ma è dura costruire un castello splendente quando le fondamenta traballano di continuo e Millie tira avanti rabbiosa, sfidando il tedio in una polarizzazione di desideri: vorrebbe un contratto “vero”, ma chi è che vorrebbe fare per sempre un lavoro così mesto? E che senso ha tirare a lucido una casa piena di cianfrusaglie da quattro soldi? Da un lato, Millie ha il lusso relativo di poter scegliere – e un minimo di spalle coperte – ma, dall’altro, le alternative a disposizione sono misere e di certo incompatibili con sogni di gloria e realizzazioni conclamate.



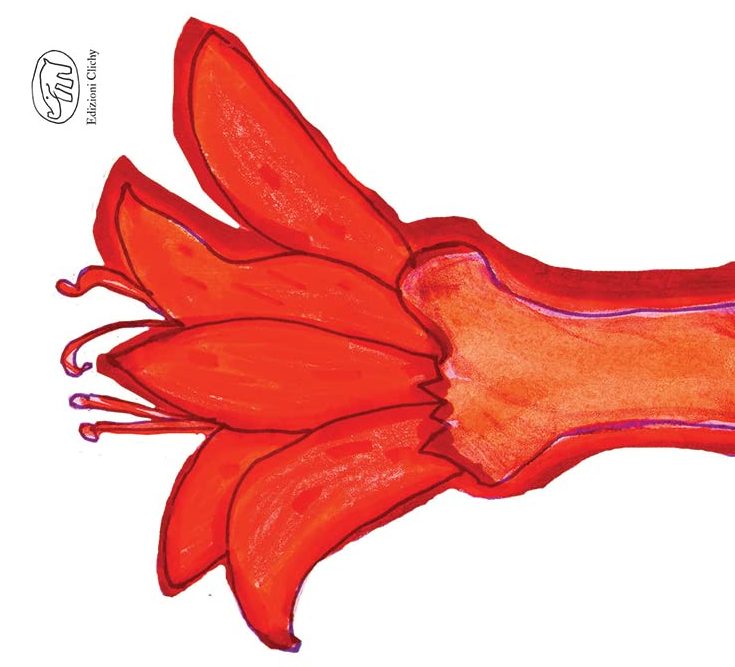






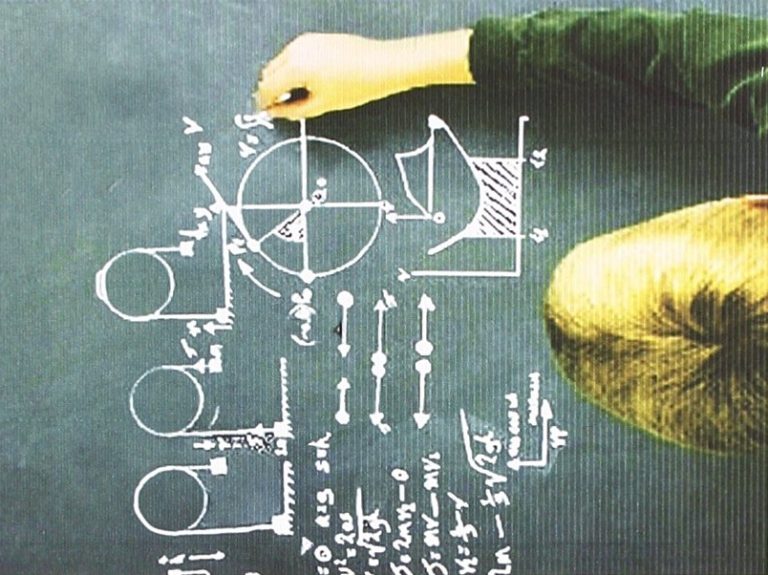
 Perché un bambino di dieci anni che tiene una conferenza ad Harvard sulla quarta dimensione non ha vie e piazze intitolate al suo genio e alle sue scoperte? Dove sono le aziende, le invenzioni, i teoremi? Perché una mente simile non ha scalfito il corso della storia? Perché – in sintesi – Sidis ha fatto la stessa fine di noialtri scemi?
Perché un bambino di dieci anni che tiene una conferenza ad Harvard sulla quarta dimensione non ha vie e piazze intitolate al suo genio e alle sue scoperte? Dove sono le aziende, le invenzioni, i teoremi? Perché una mente simile non ha scalfito il corso della storia? Perché – in sintesi – Sidis ha fatto la stessa fine di noialtri scemi?
 La Grande Era dell’Autofiction ha fatto anche cose buone? Dipende. Ci son traumi su cui si mira a costruire (con furbizia nemmeno troppo mascherata) un rimbalzo emotivo che poco contribuisce alla generale crescita del mondo attraverso la collezione di testimonianze che riecheggiano nell’universalità – così, per farvi capire le pretese che ho quando leggo storie autobiografiche – e ci sono traumi che diventano “materiale” valido perché sono sostenuti da una voce che funziona o che, come in questo caso, sperimenta sul confine sempre complicato dell’umorismo, proprio dove non ci sarebbe un bel niente da ridere.
La Grande Era dell’Autofiction ha fatto anche cose buone? Dipende. Ci son traumi su cui si mira a costruire (con furbizia nemmeno troppo mascherata) un rimbalzo emotivo che poco contribuisce alla generale crescita del mondo attraverso la collezione di testimonianze che riecheggiano nell’universalità – così, per farvi capire le pretese che ho quando leggo storie autobiografiche – e ci sono traumi che diventano “materiale” valido perché sono sostenuti da una voce che funziona o che, come in questo caso, sperimenta sul confine sempre complicato dell’umorismo, proprio dove non ci sarebbe un bel niente da ridere.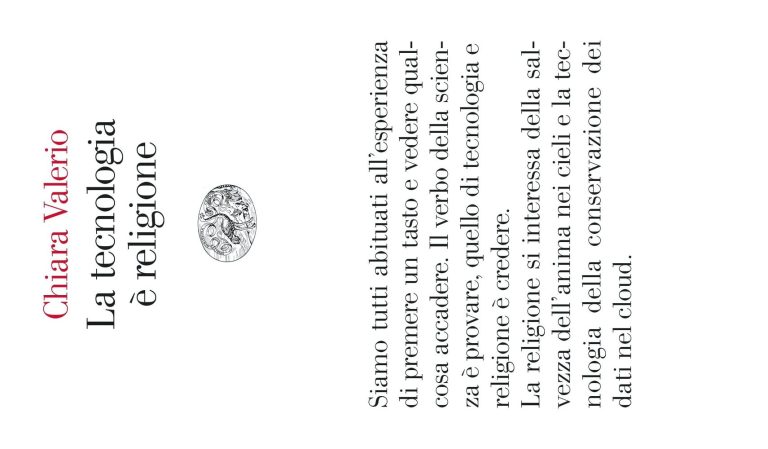
 Utilizziamo, tutti i giorni, strumenti di cui non comprendiamo il funzionamento. Anzi, strumenti che imbrigliano e sintetizzano una sterminata serie di “competenze” che non possediamo come singoli e che,
Utilizziamo, tutti i giorni, strumenti di cui non comprendiamo il funzionamento. Anzi, strumenti che imbrigliano e sintetizzano una sterminata serie di “competenze” che non possediamo come singoli e che,
 È bellissimo. Leggetelo.
È bellissimo. Leggetelo.
 Il lavoro dei miei genitori – che era stato “certo” e “fisso” sin da subito e da un’età precoce, per gli standard attuali – occupava da sempre una fetta importante delle loro giornate, ma produceva anche dei benefici tangibili. Lavoravano, ma pareva ne valesse la pena. Lavoravano, ma esistevano delle certezze materiali di cui tutti quanti potevamo godere, ricompensandoli dell’indubbia fatica che per anni han fatto pure loro. Mia madre, dopo un paio di mesi dall’inizio del mio stage, giudicava con manifesto scandalo la mia scarsa propensione al risparmio. Nell’universo in cui era abituata a muoversi lei, infatti, c’erano di certo dei sacrifici e delle decisioni da prendere, ma non c’erano affitti da pagare, futuri più incerti della media e bilanci stabilmente in passivo. Se lavori riuscirai a mantenerti. Se lavori riceverai in cambio il necessario per fronteggiare i tuoi bisogni e gestire oculatamente anche il tuo futuro. Il fatto che non si rendesse conto che, con un rimborso spese di 500€ mensili – o, più tardi, con uno stipendio da neoassunta di 1.100€ -, il risparmio fosse un lusso è un altro tassello del problema. Ero di sicuro io che non sapevo farmi valere o che non lavoravo abbastanza, ero io che non sapevo convertire l’istruzione che avevano profumatamente pagato in un impiego degno del mio blasonato ateneo. E il fatto che la mia azienda avesse un nome importante – uno di quelli che funzionano all’interno di un “ah, sì… siamo molto contenti, mia figlia lavora da…” – tendeva un po’ ad accrescere le dimensioni del paradosso, almeno dal mio punto di vista.
Il lavoro dei miei genitori – che era stato “certo” e “fisso” sin da subito e da un’età precoce, per gli standard attuali – occupava da sempre una fetta importante delle loro giornate, ma produceva anche dei benefici tangibili. Lavoravano, ma pareva ne valesse la pena. Lavoravano, ma esistevano delle certezze materiali di cui tutti quanti potevamo godere, ricompensandoli dell’indubbia fatica che per anni han fatto pure loro. Mia madre, dopo un paio di mesi dall’inizio del mio stage, giudicava con manifesto scandalo la mia scarsa propensione al risparmio. Nell’universo in cui era abituata a muoversi lei, infatti, c’erano di certo dei sacrifici e delle decisioni da prendere, ma non c’erano affitti da pagare, futuri più incerti della media e bilanci stabilmente in passivo. Se lavori riuscirai a mantenerti. Se lavori riceverai in cambio il necessario per fronteggiare i tuoi bisogni e gestire oculatamente anche il tuo futuro. Il fatto che non si rendesse conto che, con un rimborso spese di 500€ mensili – o, più tardi, con uno stipendio da neoassunta di 1.100€ -, il risparmio fosse un lusso è un altro tassello del problema. Ero di sicuro io che non sapevo farmi valere o che non lavoravo abbastanza, ero io che non sapevo convertire l’istruzione che avevano profumatamente pagato in un impiego degno del mio blasonato ateneo. E il fatto che la mia azienda avesse un nome importante – uno di quelli che funzionano all’interno di un “ah, sì… siamo molto contenti, mia figlia lavora da…” – tendeva un po’ ad accrescere le dimensioni del paradosso, almeno dal mio punto di vista.