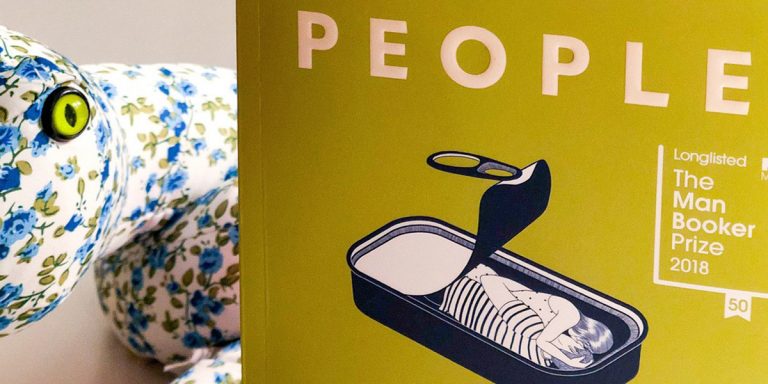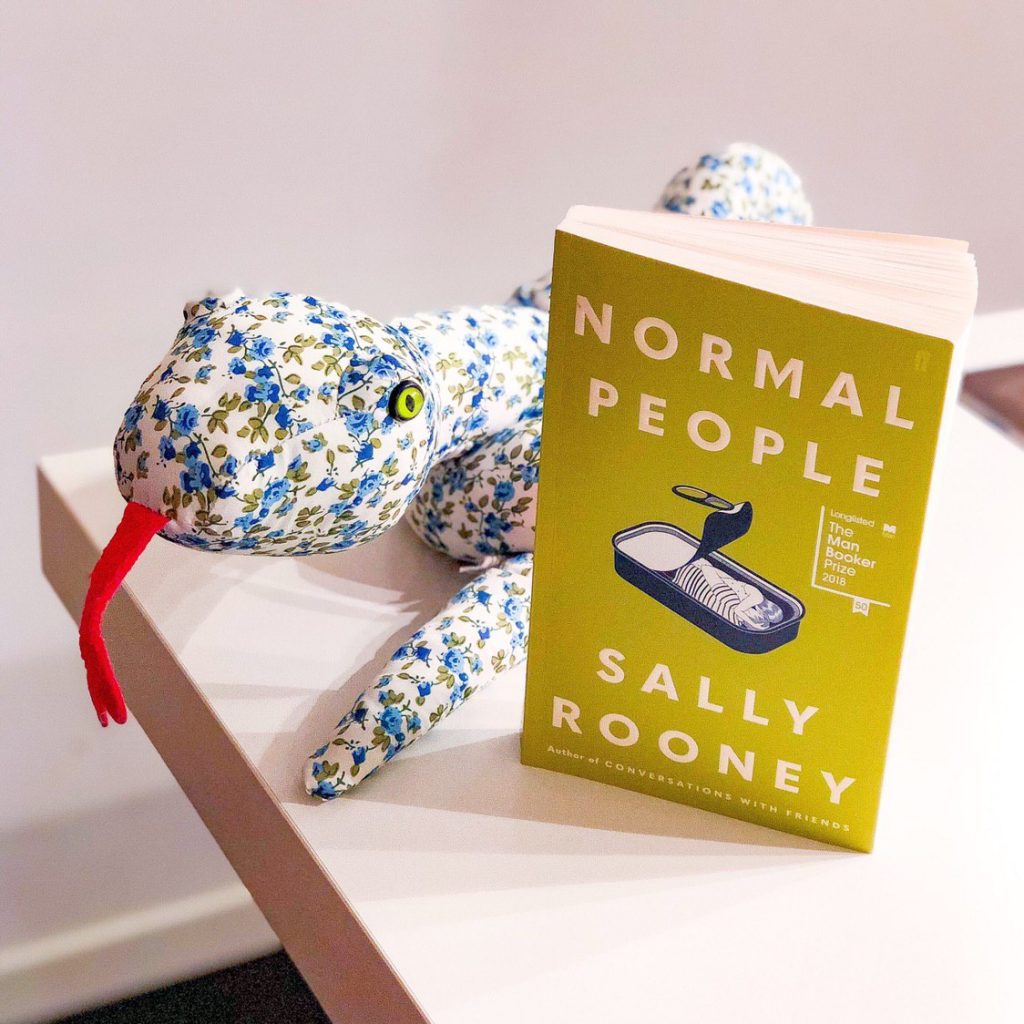Gary Shteyngart ha un talento raro: ti fa ridere di cuore, ma ti mette anche addosso una gran voglia di sederti in terra a singhiozzare un po’. I suoi personaggi si ingarbugliano nel tentativo perenne di cambiare pelle e coltivano con caparbietà le speranze più varie, deformandole fino al paradosso dell’illusione. Si muovono in mondi sovrapponibili al nostro – come nel caso di Destinazione America, uscito per Guanda nella traduzione di Katia Bagnoli – e contribuiscono a metterne in luce le storture, le ambizioni più malsane e le grandi occasioni perdute. Ho incontrato Shteyngart un mesetto fa a Torino, nel gran ribollire del Salone del Libro, e ho fatto del mio meglio per non lasciarmi annichilire dall’emozione. Sono una fan, che devo fare. Ed essere fan di un autore noto per la sua ironia e per la sua acutezza devastante è un problema ancora più grande, quando si tratta di sedersi lì e di non fare la figura della pianta da appartamento. In ogni caso, il buon Gary è stato di una gentilezza disarmante. Me lo immaginavo serafico, simpatico e brillante, avvolto in una nuvola di pessimismo divertito. E non mi sbagliavo. Spero davvero che abbia apprezzato quanto me il quarto d’ora che abbiamo passato a dirci delle cose in un cantuccio verdeggiante dell’NH Lingotto.

Due parole sul libro, prima di lasciarvi in pace a leggere l’intervista.
Destinazione America è un ritratto di Manhattan (e dell’America) alla vigilia dell’ascesa di Trump. Shteyngart ce la descrive utilizzando, in parallelo, due voci. Da un lato abbiamo Barry – “l’uomo più simpatico di Wall Street”, un finanziere che amministra hedge-fund in maniera non proprio eccezionale, ma che riesce più o meno sempre a cascare in piedi – e dall’altro c’è sua moglie Seema – figlia di immigrati indiani assai intransigenti, ha tutte le carte in regola per fare l’avvocato in uno studio prestigioso, ma ha sposato Barry e, ora, fa la signora ricca a tempo pieno. Vita idilliaca? Ovviamente no. Perché, al mondo, non tutto è in vendita. Barry e Seema partiranno ben presto per le rispettive tangenti, nel nome di una felicità che sentono di meritare ma che non sono ancora stati capaci di afferrare. Tra antichi rimpianti, Greyhound puzzolenti, autostrade che si snodano in un mondo fin troppo “reale” per gli standard di un milionario di New York, una meticolosa ossessione per gli orologi da collezione, ambizioni frustrate, scrittori boriosi, FBI e cantonate madornali, Shteyngart demolisce il sogno americano mettendo in mano il piccone proprio a due dei suoi “prodotti” di maggior successo. Che cosa resta? L’esigenza viscerale di scrollarsi di dosso le sovrastrutture e la vergogna per quello che siamo diventati, nel tentativo di riscoprirci – forse – un po’ più umani e predisposti, finalmente, all’imperfezione.
Di che abbiamo parlato? Un po’ di tutto, per mia fortuna.
Ecco qua le nostre chiacchiere.
Dobbiamo per forza partire dagli orologi, perché hanno un ruolo fondamentale all’interno del libro. E ho anche visto che le persone arrivano alle presentazioni cariche di orologi…
Oh, ma allora mi segui su Instagram! È vero. Spessissimo mi chiedono anche di autografare i cinturini! Forse pensano che la mia firma aumenti il valore dell’orologio. Credo sia vero il contrario, ma che ci dobbiamo fare.
In questo romanzo – e forse non solo lì – i soldi, insieme al tempo, sono un modo per misurare il valore di una persona.
Prima che iniziassi a scrivere questo libro, tutti i miei amici se ne stavano andando da Manhattan. I giornalisti, gli scrittori, gli artisti. Si stavano trasferendo tutti quanti perché non si potevano più permettere di vivere lì. Mi sono guardato un po’ attorno, allora. E mi sono chiesto: ma chi è rimasto? I banchieri, sono rimasti. Non c’è più nessun altro a Manhattan. Volevo parlare di loro, perché scrivo di New York e penso di dover raccontare la città così com’è… non posso creare una mia versione “inventata” di New York. Dopo qualche anno immerso in quel mondo ho cominciato a vedere tutto da una prospettiva basata sul valore. Ah, questa cosa vale TOT. Questa persona vale TOT. Vivere così è spaventoso. Poi ho fatto un passo indietro, per cercare di decomprimere. E mi sono spostato anch’io. Ora vivo a nord, per una metà dell’anno, in un piccolo centro a dure ore dalla città. E là posso concedermi di essere normale. Anche un sacco di miei amici che si sono trasferiti ormai vivono lassù, perché se lo possono permettere.
È un tema che abbiamo già incontrato, mi pare. In Storia d’amore vera e supertriste tutti hanno una specie di cartellino virtuale che fluttua sopra le loro teste e che mostra al mondo il loro valore.
Esattamente. Penso sia una conseguenza diretta dell’aver vissuto così a lungo a New York, quest’idea che ciascuno di noi abbia un numerino che lo qualifichi. Vale anche per Trump, che vuole continuare a farci credere che il suo numerino sia molto alto… anche se in realtà non lo è affatto.
C’è parecchio Trump, in questo libro. Quando hai iniziato a lavorarci?
L’ho scritto nel 2016, quando non era ancora diventato presidente. Credevamo che sarebbe rimasto un po’ in ballo nella corsa elettorale, ma nessuno pensava che potesse vincere. E poi, man mano che procedevo con il libro, mi sono ritrovato a dover aggiungere sempre più Trump… perché il 2016 stava andando in quella direzione.
Ecco, non mi ricordo a memoria il passaggio, ma a un certo punto c’è una frase che dice più o meno così: “Se sono così ricchi è impossibile che siano stupidi”.
[Ride].
È uno dei grandi falsi-miti americani. Si pensa che la gente ricca sia anche incredibilmente intelligente. Barry, ovviamente, è molto ricco… ed è convinto di voler aiutare le persone. Ma le sue idee sono di un’idiozia assoluta. Vorrebbe istituire questo Urban Watch Fund per aiutare i ragazzini dei ghetti a comprarsi il loro primo Rolex. Eccomi qua, mi sto prendendo cura di voi!
Imprescindibile. In America è quasi obbligatorio che i “ricchi” diano l’impressione di voler aiutare la comunità con raccolte-fondi, iniziative benefiche, gran cene di gala. Ma vivono comunque in un universo completamente scollato da quello delle comunità che dovrebbero beneficiare della loro grande magnanimità. Che ne sanno?
Ma niente. Niente. Vivono in un mondo in cui esiste il loro club esclusivo di Midtown, il loro ufficio, la loro villa negli Hamptons. È un mondo veramente noioso. Io adoro mangiare… e in quei club il cibo è pessimo. Non so come facciano a campare così. Ho iniziato a portarli in giro per ristoranti. Ristoranti indiani, ristoranti veri. “Oh, santo cielo, che buono, ma pensa!”. E hanno scoperto che si può mangiare qualcosa di incredibile per molto meno di 100 dollari a piatto.

In questo romanzo ci sono due punti di vista diversi. Abbiamo Barry, che parte per il suo viaggio – e chissà dove andrà a finire – e poi c’è Seema, sua moglie. Lei è una donna brillante, una che potrebbe farcela benissimo da sola, senza accalappiare un marito in mezzo agli hedgie di Wall Street. Che le è capitato?
La domanda non è solo cosa è capitato a lei, ma cosa è capitato a centinaia e migliaia di persone come lei. Incontravo di continuo mogli come Seema. Donne più intelligenti dei loro mariti, con un curriculum migliore di quello dei loro mariti. Quando si sposano, però, fanno due conti e cominciano a pensare che tutto sommato non valga più la pena lavorare. E si crea questo sistema sociale… futile. La moglie scorta i principini verso il futuro, punto e basta. È un sistema assolutamente misogino, che non aiuta nessuno. Ma immagina di essere il figlio di una queste mogli… che cosa fa la mamma? La mamma ha una laurea migliore di quello di papà ma passa tutto il suo tempo a escogitare un modo per far entrare il suo bambino ad Harvard. È davvero avvilente.
E le operazioni iniziano dall’asilo?
Iniziano dal nido, per certe scuole. Ho un bambino piccolo anch’io e quando abbiamo provato a iscriverlo – avrà avuto un anno, più o meno – ci hanno spiegato che no, la domanda va fatta pre-nascita. Insomma, se fai sesso e hai anche solo il sentore di aver concepito, la mattina dopo devi prendere il telefono e chiamare SUBITO. Salve, sì, abbiamo fatto l’amore proprio bene… potete tenerci un posto?
[COPIOSE RISATE NON TRASCRIVIBILI]
Uno dei veri problemi, in un contesto di questo tipo, è la gestione di quello che va storto. Ed è quello che capita a Barry e Seema. Loro figlio non è il bambino che si immaginavano, non sarà mai il principe che governerà il mondo. E non riescono ad accettarlo.
Esatto. Il loro bambino si colloca da qualche parte all’interno dello spettro autistico. La vita di Barry e Seema è strutturata per avanzare e convergere verso la perfezione – Barry per la sua infanzia tremenda, Seema per la severità dei genitori immigrati. Devono avere successo, ad ogni costo. E spunta una crepa, in mezzo a tutto questo. Per loro è così devastante da non poterlo nemmeno dire apertamente, Seema non può parlarne ai suoi. Devono far finta che vada tutto bene… ed è tragico, anche per il bambino.
Seema ha una cartella di foto sul telefono in cui Shiva sembra “normale”. E usa solo quelle foto, quando si tratta di far vedere suo figlio agli altri. All’inizio del libro vanno a cena dai loro vicini, che hanno questo bimbo perfetto che canta e recita filastrocche. E per loro è un’esperienza assolutamente mortificante.
Li distrugge. E Barry pensa, “ma com’è possibile? Io ho molti più soldi di loro! Mio figlio dovrebbe essere meglio del loro!”.
I soldi aiutano, ma a loro mancano proprio le basi di un rapporto umano significativo.
Non solo. Barry fa la spola da un’università all’altra distribuendo donazioni nella speranza che qualcuno smentisca la diagnosi di suo figlio.
E poi parte per il suo viaggio, che si trasforma in un’avventura comica e surreale. È come se vedesse il mondo per la prima volta. Oh, guarda, un Walmart!
Esatto! Ho un sacco di azioni di Walmart, ma non ne avevo mai visto uno! Incredibile!

Barry ha anche un’assistente che si occupa di ogni dettaglio della sua vita. Man mano che il viaggio procede, però, comincia a separarsi dalle sue carte di credito, dal telefono… che cosa rimane di Barry?
È proprio quello il domandone. Gli americani sono convinti che la loro vita sia composta da numerosi atti. Certo, si comincia col primo atto… ma puoi sempre diventare una persona diversa. È un paese grande, se vuoi trasferirti nel sud-ovest per allevare bestiame in un ranch o spostarti chissà dove per coltivare avocado lo puoi fare. In realtà, però, sei sempre la stessa persona. Quel che manca, a volte, nella mentalità americana, è la consapevolezza che dopo un po’ di tempo – quando ormai ha superato l’infanzia – non cambi più per davvero. Barry decide di partire per riscoprirsi, vuole ritrovare la sua fidanzata storica, fare questo, fare quello… ma alla fine è sempre lo stesso schmuck di prima.
Quando va a cena con i genitori della sua ex fidanzata si trova davanti a due persone paralizzate dall’imbarazzo, che cercano in tutti i modi di dirgli – invano – che il passato è passato.
Il passato è passato. La reazione di Barry? “Oggi posso comprarmi questo passato. Se solo avessi sposato la mia ragazza del college, tutto sarebbe andato in un’altra maniera”.
Verissimo. Sono tutti alle prese con un rimpianto antico o con un errore a cui cercano di porre rimedio. Forse è ormai un luogo comune… ma è possibile che nel sogno americano qualcosa sia andato storto?
Molto storto. Anzi, potremmo dire che è finito. Ma è stato bello, per un po’. Tutto finisce. E questa è un’altra cosa che gli americani non capiscono. Pensano di essere un paese eccezionale – non è mai esistito niente di così straordinario! – ma abbiamo avuto l’impero romano, il dominio spagnolo, l’impero mercantile olandese, l’impero cinese… è come un giro sulle montagne russe. E ora la parabola è decisamente discendente.
Forse è anche una conseguenza dell’economia che abbiamo costruito. Le cose vanno male ma non comprendiamo a pieno le cause… anche se siamo stati proprio noi a creare quel sistema.
Quando un sistema diventa ipercomplesso, com’è ora, è l’inizio della fine…
*
Grazie a Guanda per aver ritagliato un po’ di tempo anche per me nell’agenda massacrante del buon Gary. E grazie soprattutto a lui per le splendide chiacchiere. E per questo libro, che come sempre ci fa disperare per la spietata limpidezza di quel che ci restituisce… ma ci fa anche sguazzare con vero divertimento nell’arte nobilissima del paradosso.
🙂
*
 Allora, se il vostro obiettivo è approcciarvi a una scrittura estrosa, guizzante, ricca e succulenta – ECCO, qua non gira esattamente così. Lo stile ragionieristico giapponese – iper funzionale, precisino e fondamentalmente anonimo – colpisce ancora… e devo confessare che un po’ patisco questa strutturale impossibilità di distinguere una voce dall’altra. Di buono c’è che non si sconfina nella pedanteria e nella ripetitività e che, forse proprio per l’atmosfera piana e per l’assenza di arzigogoli, I miei giorni alla libreria Morisaki – tradotto da Gala Maria Follaco per Feltrinelli – vi filerà via liscio e finirete per leggere con gran lena. Menate mie a parte, è un romanzo che come campo-base sceglie una libreria piacevolmente sgangherata di Tokyo, collocata nel quartiere con la più alta concentrazione di librerie al mondo – Jinbōchō.
Allora, se il vostro obiettivo è approcciarvi a una scrittura estrosa, guizzante, ricca e succulenta – ECCO, qua non gira esattamente così. Lo stile ragionieristico giapponese – iper funzionale, precisino e fondamentalmente anonimo – colpisce ancora… e devo confessare che un po’ patisco questa strutturale impossibilità di distinguere una voce dall’altra. Di buono c’è che non si sconfina nella pedanteria e nella ripetitività e che, forse proprio per l’atmosfera piana e per l’assenza di arzigogoli, I miei giorni alla libreria Morisaki – tradotto da Gala Maria Follaco per Feltrinelli – vi filerà via liscio e finirete per leggere con gran lena. Menate mie a parte, è un romanzo che come campo-base sceglie una libreria piacevolmente sgangherata di Tokyo, collocata nel quartiere con la più alta concentrazione di librerie al mondo – Jinbōchō.



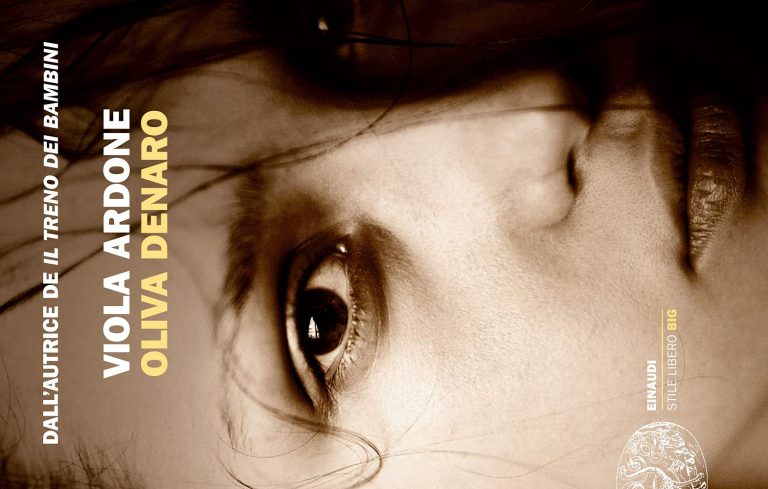
 Come parecchie lettrici e lettori, ho fatto amicizia con Viola Ardone grazie al
Come parecchie lettrici e lettori, ho fatto amicizia con Viola Ardone grazie al 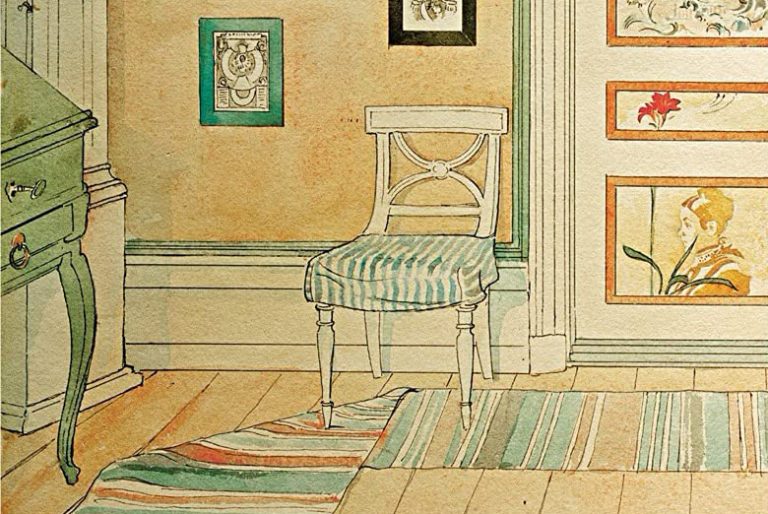
 Mentre l’umidità ci assedia, la pioggia battente ci flagella e cerchiamo di venire a patti con l’oscurità incombente – giuro, mai capirò che cosa diamine dovremmo farcene di un’ora in più di luce fioca al mattino quando potremmo beneficiare di pomeriggi più lunghi E INVECE NO TRASFORMEREMO LE VOSTRE GIORNATE IN UNA TOMBA UMIDA DI BUIO ALLE 15.23 SCUSATE PATISCO MOLTISSIMO IL MESE DI NOVEMBRE -, dicevamo, mentre il panorama attorno a noi si fa desolante e la speranza ci abbandona a poco a poco,
Mentre l’umidità ci assedia, la pioggia battente ci flagella e cerchiamo di venire a patti con l’oscurità incombente – giuro, mai capirò che cosa diamine dovremmo farcene di un’ora in più di luce fioca al mattino quando potremmo beneficiare di pomeriggi più lunghi E INVECE NO TRASFORMEREMO LE VOSTRE GIORNATE IN UNA TOMBA UMIDA DI BUIO ALLE 15.23 SCUSATE PATISCO MOLTISSIMO IL MESE DI NOVEMBRE -, dicevamo, mentre il panorama attorno a noi si fa desolante e la speranza ci abbandona a poco a poco, 
 Daniele è già stato in cura e ha sperimentato una nutrita sfilza di farmaci, ma continua a non digerire l’indifferenza con cui il mondo distribuisce sofferenza, assurdità arbitrarie, accidenti e disastri. È come se gli mancasse la pelle, quel minimo di scorza che rende sopportabile l’immagine del futuro. Vorrebbe proteggere chi ama, vorrebbe trovare un angolo di pace dove rifugiarsi quando riaffiora il pensiero che sforzarsi è inutile, perché tutto è destinato a sbriciolarsi e a svanire. Come si può gestire il presente se non vediamo altro che la polvere che resterà di noi?
Daniele è già stato in cura e ha sperimentato una nutrita sfilza di farmaci, ma continua a non digerire l’indifferenza con cui il mondo distribuisce sofferenza, assurdità arbitrarie, accidenti e disastri. È come se gli mancasse la pelle, quel minimo di scorza che rende sopportabile l’immagine del futuro. Vorrebbe proteggere chi ama, vorrebbe trovare un angolo di pace dove rifugiarsi quando riaffiora il pensiero che sforzarsi è inutile, perché tutto è destinato a sbriciolarsi e a svanire. Come si può gestire il presente se non vediamo altro che la polvere che resterà di noi?
 Che accade in questo libro? Dipende dall’occhio.
Che accade in questo libro? Dipende dall’occhio.