Ci siamo, il Natale sta per assalirci.
Cosa donare ai consanguinei?
Cosa regalare a chi ha saputo conquistare il nostro affetto?
Un libro va sempre bene? Giammai! Funziona se lo si sceglie con cura e se risponde con allegra puntualità a un interesse o a una passione – e magari anche a una più che legittima inclinazione estetica. Insomma, questo fanno le strenne: sono libri belli o edizioni pazze e preziose, sono libri ben delimitati dal punto di vista tematico, sono libri estrosi che si lasciano associare volentieri alle fissazioni e alle curiosità dei destinatari. La premessa metodologica di queste liste festive è sempre la stessa, ma trovo sensato ripeterlo anche per il 2025.
In caso di ulteriori necessità esplorative, al fondo trovate i rimandi anche alle edizioni passate di queste carrellatone.
Ultima nota e poi si parte: liberissimi e liberissime di segnarvi su un pezzo di carta le proposte che troverete qua dentro per andarvele a comprare in libreria, senza necessariamente avvalervi dei link (sì, sono affiliati).
A posto? A posto.
Sproniamo le renne, si parte!

Margaret Atwood
Le nostre vite. Una specie di autobiografia
(Ponte alle Grazie)
Traduzione di
Che ci si meravigli (e spaventi) con le sue ancelle o che ci si addentri nella testa delle temibili Zie di Gilead o che la scintilla per Atwood si sia messa a crepitare partendo da un altro tra i suoi innumerevoli romanzi, Le nostre vite è l’avventura definitiva e rallegrerà di certo chi già coltiva una sana fandom per l’autrice canadese, che qui si racconta con franchezza, godibilissima perfidia e grande generosità.
P. S. Se vi va di donare Il racconto dell’ancella e I testamenti, ecco qua uno splendido cofanetto.

Renaud Roche & Laurent Hopman
Le guerre di Lucas. Episodio II
(BAO Publishing)
Potremmo litigare per ore sulla parabola filmica dell’universo di Star Wars – quale trilogia “nuova” ha maggiormente suscitato il vostro sdegno? Come è stato possibile concepire quella cazzata dei midichlorian? Vogliamo parlare di Jar Jar Binks? Come diamine hanno resuscitato l’imperatore Palpatine? – ma l’impatto di George Lucas sui nostri immaginari e sulla storia del cinema resterebbe saldo e indubitabile. Roche e Hopman hanno iniziato a raccontare il making-of di A New Hope nel primo volume delle Guerre di Lucas e proseguono qui il viaggio. Auspico per questa serie un’estensione su nove tomi, ma vediamo come si mette. Se la forza scorre potente in casa vostra, ficcateli entrambi sotto l’albero.
P. S. L’ultimo set Lego di Star Wars che ho costruito potrebbe essere un buon elemento d’accompagnamento.

Sofia Fabiani
Il dolce. Basi e ricette di pasticceria
(Gribaudo)
Per la rubrica “i social hanno fatto anche cose buone”, eccoci qua a impiastricciarci di pastafrolla con @cucinarestanca. È di certo una proposta editoriale più “tecnica” rispetto ai suoi libri precedenti – Cucinava sempre e Cucinare stanca. Manuale pratico per incapacy – e che conferma la sua ferrea competenza e la rara capacità di renderla accessibile. Insomma, funzionerà benone per chi vuole partire dai fondamentali della pasticceria e lanciarsi in esperimenti estrosi dopo aver imparato almeno a camminare. E un cuore a Sofia.
Altri spunti legati alle cibarie?
Per chi vuole fare il pane c’è questo bel manuale a fumetti di Ken Forkish e Sarah Becan (Quinto Quarto). Robin Ha vi insegna – sempre a fumetti – a cucinare koreano. Volete semplicemente ammirare dei meloni e delle angurie stupende? C’è un’enciclopedia a tema che ha tutte le fattezze di un coffee-table smorfioso. A tal proposito, vi rammento che è sempre possibile scoprire ricette strabilianti e contemporaneamente fare del bene ai civili palestinesi con l’ebook di Cocomero & Friends.

Coco Wyo
Posticini carini – Colora la tenerezza
(Magazzini Salani)
Per Coco Wyo è partito un sommovimento internazionale di fulgido amore – che ha inevitabilmente generato anche una valanga di copycat orrendi generati dall’IA. Senza lasciarci ingannare, dunque, che fa il collettivo Coco Wyo? Ha rivitalizzato l’ormai saturo mercato dei coloring book proponendo innanzitutto degli angoletti confortevoli e degli ambienti armoniosi – per quanto zeppi di roba – in cui sarebbe bello poter sostare. Oltre a Posticini carini, troverete anche Soffici cuccioli e Coccole a Natale. Forse mi starò rincoglionendo, ma sono assolutamente rapita. SOFFICI CUCCIOLI CAPITE?!

Marion Montaigne
I nostri mondi perduti
(BAO Publishing)
Che Zerocalcare ficcasse prima o poi una graphic novel piena di dinosauri nella collana Cherry Bomb – che sta curando per BAO – era un po’ il segreto sogno di tutti quanti. Ebbene, ci siamo. I nostri mondi perduti è una vastissima ricognizione paleontologica che mescola storia della scienza e cultura pop, divulgazione e cruente dispute evoluzionistiche. Ottima idea, Zerocalcare.
Altri dinosauri? C’è Andrea Cau – esimio paleontologo – con Il dilemma dei dinosauri, un saggio a tratti dolorosissimo che spiega per filo e per segno da dove vengono le bestie a sangue caldo di Jurassic Park e perché non dovremmo prenderle per buone. Lo so, è un duro colpo… ma è anche un efficace spaccato di storia recente della paleontologia. Volete saperne di più? Qua ci siamo noi che facciamo una chiacchiera.
Preferite continuare a crogiolarvi nel vostro affetto per Spielberg? Ecco una latta di schiuma da barba da usare come borraccia – sì, è quella che Dennis Nedry voleva riempire di embrioni di dinosauro. Capolavoro.
Ma abbiamo anche un libro sul making-of di Jurassic Park A FORMA DI VHS.
Potrei andare avanti delle ore, ma preferisco concludere il capitolo dinosauri con questa lista tematica che contiene sia proposte per grandi che per piccoli.

Dante
Divina Commedia | Inferno
(Blackie edizioni)
Blackie continua ad alimentare la sua collana/progetto dei Classici Liberati e, dopo Iliade, Odissea e Genesi, ci manda allegramente all’Inferno con Dante e tutti i suoi illustri peccatori. L’idea, come sempre, è quella di accompagnare a un’opera fondamentale una serie di apparati che possano attenuarne gli aspetti potenzialmente ostici e “farci mondo” attorno.
Volete recuperare un’iconografia così solida da essere quasi diventata “canonica” per la Commedia? L’Ippocampo ne ha ficcata parecchia in Fantastico Gustave Doré, librone-retrospettiva della sua produzione più visionaria.

Mary Shelley feat. Minalima
Frankenstein
(L’Ippocampo)
Vista l’ondata d’entusiasmo collettivo per i “mostri” classici, segnalo il ritorno dei Minalima alla loro collana di preziosi illustrati pieni zeppi di trovate cartotecniche. Da quel che m’è parso di capire dalla quarta, il testo di quest’edizione dovrebbe essere quello del 1818. Parte dall'”originale” del 1818 anche il Frankenstein illustrato da Marco Calvi e tradotto da Tiffany Vecchietti uscito per ReBelle Edizioni – che vi segnalo con ancora più entusiasmo.
Servono approfondimenti sulla genesi dell’opera? Kathryn Harkup ha ricostruito la parabola biografica di Mary Shelley in La nascita di Frankenstein (Utet), mettendo particolarmente in risalto il precipitato delle conoscenze scientifiche dell’epoca nel romanzo.
Per la falange del cinema, invece, Guillermo del Toro ha raccolto in un libro la storia produttiva del “suo” Frankenstein. Come i migliori art-book cinematografici, è un oggetto di rara beltà… anche se chi ha amato con passione il recente adattamento forse s’accontenta anche di una semplice foglia secca.

Altri spunti per donare dei classici in edizioni illustrate di grande formato? Dall’Ippocampo trovate la collana Papillon Noir che fa proprio quello. Per ora ci sono Cime tempestose, Il grande Gatsby e Il ritratto di Dorian Gray.
Volete stare sul perturbante? Bur ha sfornato Weird, una nuova collana dalla veste grafica molto gagliarda. Al momento ci trovate Ann Radcliffe con I misteri di Udolpho, Fosca di Tarchetti, Il re in giallo di Robert W. Chambers e Alle porte dell’incubo di Poe.

Jonathan Wilson
La piramide rovesciata – La Bibbia della tattica nel calcio
(Limina)
Chi apprezza il GIUOCO del pallone non potrà che accogliere con gioia questo autorevole saggio che è sia una “storia del calcio” che una ricognizione tattica e un atlante cultural-sportivo. Ci troverete dentro filosofie, grandi allenatori, campioni, colpi di genio e, forse, anche lo scheletro della squadra perfetta.
Se in casa (come la sottoscritta) avete una persona abbonata alla Riserva, segnalo anche Il mito dei bomber di provincia del prode Emanuele Atturo (Einaudi).

Adriano Panatta & Paolo Bertolucci
La telefonata – Gli Slam del 2025
(Fandango)
Intanto che ci occupiamo di sport, mi pare sensatissimo pensare al tennis e a chi il tennis lo ama – o ha imparato ad apprezzarlo di recente. Fa niente se noi c’eravamo già, bisogna accogliere volentieri anche i tifosi e le tifose dell’ultima ora. Panatta e Bertolucci a tennis ci hanno giocato con gloriosi risultati e ormai da un pezzo si dedicano al commento del loro sport, ritagliandosi anche un podcast divertentissimo in cui un po’ parlano dei tornei più importanti del circuito e un po’ si prendono per il culo. Ecco, in questo libro ci sono gli Slam del 2025, più o meno come li abbiamo ascoltati.
Ma qualcosa su specifici campioni? Limina vi soccorre, per il momento, con Novak e Alcaraz, entrambi di Mark Hodgkinson.
Il tennis come esperienza estetica? Emanuele D’Angelo di Broken Rackets ha sfornato Paradise Courts, un volume fotografico avvenente e smorfiosissimo che censisce i campi da tennis più belli del mondo.


Masato Tanaka & Shuzen Iwata
La storia universale in infografica
(Vallardi)
Traduzione di Nicola Emanuele Jacchia
Mia personalissima fissazione, gli atlanti e/o i libri divulgativi con i grafici, le mappette e le illustrazioni MAI MANCHERANNO IN QUESTI LISTONI. Qui, con l’ausilio di inesauribili trovate visive e coccosi personaggetti tondeggianti, si parte dalla preistoria per approdare alla storia novecentesca e ai più recenti disastri, sintetizzando l’impossibile e producendo una piacevole infarinatura che incoraggia approfondimenti ulteriori.
Se vi garba il genere o sapete a chi potrebbe garbare, vi segnalo anche Le operazioni della Seconda Guerra Mondiale in 100 mappe della premiata ditta Lopez-Aubin-Bihan per l’Ippocampo.
Illustrazioni vispe per spiegarsi meglio? Ci sono anche nel saggio di Alessandro Maccarrone per Blackie, L’infinito piacere della matematica. Là fuori, evidentemente, c’è qualcuno che la capisce e sa addirittura renderla comprensibile.

Ximo Abadìa
Verticale – Storia illustrata dell’arrampicata
(Quinto Quarto)
Amiche e amici in fissa con l’arrampicata? Congiunti, sodali d’escursione, gente che ama scarpinare in salita – e non solo perché al rifugio c’è la polenta da mangiare? Perfetto, abbiamo un illustrato pronto a raccontarci la perigliosa e affascinante storia dell’esplorazione montana, dai primi geloni alle più recenti competizioni canonizzate.
Un libro potenzialmente affine? Visionario ribelle, la storia di Yvon Chouinard, fondatore di Patagonia.
Un libro che si tuffa in un ambiente tradizionalmente percepito come opposto alla montagna? Ecco qua Mare di Piotr Karski – sempre edito da Quinto Quarto. È uno di quegli albi ibridi che possono essere apprezzati da bambini, grandi, medi, tutti quanti. Oltre a raccontare mari e oceani con imprevedibile creatività, contiene anche numerosissime attività buffe da svolgere.

Marracash
Qualcosa in cui credere – La mia trilogia
(Rizzoli Lizard)
Niente, al Marrageddon è poi finita che non ci sono andata perché quando avevamo comprato i biglietti non avevamo valutato che in casa ci sarebbe stato un bambino di un paio di mesi da accudire e a sentire Marra ci sono andati mio marito e il mio giovane cognato. Io no, a casa col Dadani. Al di là delle mie vicissitudini personali, i musicisti tendono a far uscire dei libri che sono più assimilabili a gadget fotografici che a qualcosa che si può leggere davvero, ma questo malloppo di Marracash è un oggetto che credo gli faccia onore e che aggiunge tassellini degni d’interesse a Persona, a Noi, loro, gli altri e a È finita la pace. Se ascoltate Marra o cercate qualcosa per chi lo apprezza e ha apprezzato la sua recente trilogia musicale, Qualcosa in cui credere è uno spunto validissimo.
Per chi invece era con me a sudare a San Siro con delle bottigliette rigorosamente senza tappo (e senza ghiaccio) di vodka lemon in mano, ricordo sempre che esiste un’autobiografia di Gabry Ponte. SI VOLA. 😀
Intanto che ci siamo: lo sapevate che anche Max Pezzali ha raccontato la sua storia in un libro? Si chiama I cowboy non mollano mai.

Flavio Parisi
Tokyo è una grande cucina – I giapponesi si conoscono a tavola
(Utet)
Di Flavio Parisi s’era già parlato da queste parti per il suo primo lavoro Giappone-centrico – Cadere sette volte, rialzarsi otto era una riflessione sull’apprendimento di una lingua ostica mentre si vive in un posto affascinante e anche profondamente “alieno”. In questo nuovo libro si torna a Tokyo per raccontare il paese e i suoi abitanti attraverso la cucina, le abitudini a tavola e la convivialità. Il cibo è un potente veicolo culturale e mangiare in Giappone è senza ombra di dubbio un’esperienza mistica.
Ci sono splendidi viaggi in cantiere? Eriko Kawasaki aka Erikottero può soccorrervi con Easy Japan (Longanesi), un manuale linguistico dalla spiccata vocazione pratica che saprà anche darvi una mano nel decifrare comportamenti e forme di cortesia. Non sono usciti ieri, è vero, ma sia I love Tokyo che I love Japan della Pina restano delle piacevolissime guide.

Vi risparmio le librerie con l’inevitabile gatto saggio, le botteghe di quartiere dove tornare ad apprezzare il senso della vita, i baretti e i negoziucci che garantiscono rinascite personali ma credo sia il caso di salutare con favore il ritorno di Antonietta Pastore – pioniera della traduzione letteraria dal giapponese all’italiano – al tema della vita in Giappone. Seguito ideale di Leggero il passo sui tatami, Dove vuole andare, sensei? (Einaudi) è un nuovo reportage sentimental-pratico che abbraccia una lunghissima frequentazione diretta – cominciata nel 1974 e mai interrotta.
Un altro graditissimo ritorno? C’è Laura Imai Messina con Le parole della pioggia, illustrato da Emiliano Ponzi.
E i manga? Da vecchia ciabatta quale sono, non posso non menzionare l’edizione completa per i 30 anni di I cortili del cuore di Ai Yazawa.

Roberto Alajmo – Marco Carapezza
Avventure postume di personaggi illustri
(Sellerio)
Per la quota cimiteriale – che mai deve mancare -, un saggio snello e favolosamente folle sulle vicissitudini di dieci salme ragguardevoli. Gente che da viva ha fatto la storia e che, da morta, si sarebbe forse meritata un destino meno rocambolesco.
Approfitto dell’atmosfera vagamente sinistra di questo blocco per rammentare che è uscito un nuovo romanzo di Michele Mari, I convitati di pietra, una storia che affosserà per sempre la già scarsa reputazione delle rimpatriate del liceo.

Iacopo Bruno & Francesca Leoneschi
Inseparabili
(Rizzoli)
Nelle profondità di un oceano sconosciuto, un piccolo polpo piange il padre scomparso e abbandona il regno per ripescare la sua anima da un abisso scurissimo. Sempre là sotto, lo spettro di una bambina che ha perso il cuore in un naufragio cerca consolazione. Si incontreranno? Certo. I disegni di Iacopo Bruno, qui, meriteranno tutto il vostro più sincero stupore.
Un altro romanzo – teoricamente per ragazzi – che può allietare sia per inventiva che per cura dell’edizione? Cesare vi consiglia L’ordine dei Senzasonno di Isaak Friedl per Giunti.

Stefano Zuffi
Animali dipinti
(24Ore Cultura)
Per le bimbe e i bimbi di Michel Pastoureau, un atlante ragionato degli animali nell’arte. Attraversando epoche e tradizioni pittoriche, Zuffi cataloga le bestie dalla simbologia più nutrita, inserendole nel loro habitat iconografico di riferimento e offrendoci numerosi capolavori da ammirare.
Più scienza e meno arte? Roberta Ragona – aka Tostoini – ha firmato per Aboca Fossili viventi – Le straordinarie creature del passato che vivono tra noi. Per un approccio estremamente attivo e partecipato all’evoluzione, invece, c’è Evolution Book. Estinguiti o sopravvivi, un libro a bivi che vi spronerà a decidere che bestia diventare – e a capire perché certe creature proprio non ce l’hanno fatta.

Daniel Keyes
Fiori per Algernon
(Nord)
Uscito nel 1966, il topolino Algernon e il “suo” scienziato riappaiono per Nord tirati a lucidissimo con il trattamento superlusso. Labirintico taglio colore! Risguardi matti! Un modo intelligente per rinfrescare un romanzo che vale la pena continuare a leggere.
A proposito di romanzi che appaiono con particolare cura nel confezionamento – e che possono tornarvi utili nel caso ci sia già dell’apprezzamento per le autrici: Noi di Christelle Dabos (e/o) e Katabasis di R. F. Kuang (Mondadori).

Jane Austen
I capolavori
(Newton Compton)
Per i 250 anni dalla nascita dell’autrice sono state più che legittimamente sfornate numerose proposte editoriali, spesso e volentieri rivolte a un pubblico giovane, vispo e assai abituato al taglio colore di cui sopra, alle copertine gradevoli da vedere e a un impianto di publishing meno polveroso rispetto a quello che noi rognosi e rognose millennial abbiamo esperito. In questo filone si inserisce anche il cofanetto completo delle opere di Jane Austen prodotto da Newton Compton con la curatela di Felicia Kingsley – cofanetto che da ragazzina, ve lo dico, mi sarebbe parecchio piaciuto ricevere. E invece.
Vogliamo esplorare la vicenda biografia di Jane Austen? Carolina Capria la ripercorre con precisione, affetto e passione in Per sempre tua: il mondo infinito di Jane Austen (Gribaudo).
Vogliamo frazionare i romanzi di Jane Austen per potercene gustare un frammento tutti i giorni? Liliana Rampello ha curato Un anno con Jane Austen (Neri Pozza), una raccolta di 365 scene memorabili, dialoghi e citazioni.
Servono strumenti per orientarsi meglio? Ecco qua la mappa letteraria di Orgoglio e pregiudizio (il Saggiatore).

Daniel Wallace
Big Fish
(il Saggiatore)
Traduzione di Silvia Lalia
Sempre ci accapiglieremo su trasposizioni e adattamenti, ma risalire ai materiali originali di film molto fortunati o emblematici è sempre un esercizio fascinoso. Ebbene, anche Big Fish arriva da un libro… ci uniamo al circo?
Altri recenti e curiosi esempi? Abbiamo K-PAX di Gene Brewer (Accento), Ammazzati amore mio di Ariana Harwicz per Ponte alle Grazie – da cui è stato tratto Die My Love, in arrivo al cinema – e Lezioni di chimica di Bonnie Garmus (di cui si era parlato anche qui).
Attori che scrivono? Minimum Fax ha appena tradotto The Book of Elsewhere di Keanu Reeves e China Mieville. Per approfondire vi rimando qui.

Ludovica Lugli
Le chiavi magiche
(Utet)
Ludovica Lugli ha scelto un sottotitolo pacato e modesto, che fa così: “Indagine di una lettrice su Elsa Morante e i suoi romanzi”. Non sta mentendo, perché Le chiavi magiche è esattamente un viaggio nei libri di Morante, in quello che ci hanno lasciato e in quello che potevano dirci sia di lei che della sua epoca, ma a quel “lettrice” avrei aggiunto “lettrice molto accorta, molto acuta, molto sveglia, proprio una brava lettrice”. Veniva lungo? Sì, ma ci voleva.
Un approccio più “visivo” al Morante-verso? Per Einaudi è uscito Album Morante, un volume curato da Emanuele Dattilo che raccoglie lettere, fotografie e parecchi materiali inediti che ricostruiscono il mondo e il contesto personale e culturale dell’autrice.
Un altro volumone fotografico einaudiano – che si posiziona saldamente nel solco della nostalgia mondana e cinematografica? Francesco Piccolo ha firmato e “organizzato” Paparazzi, una raccolta di un’ottantina di scatti emblematici dell’epoca d’oro della “dolce vita”. Non vogliamo scansarci da Cinecittà? Olivia Laing torna al romanzo con Lo specchio d’argento (il Saggiatore) e sceglie di ambientarlo proprio lì, sul set del Casanova di Fellini.

Jean Jullien
This Is Not a Book
(Phaidon)
“Qual è il tuo libro preferito?”: quando me lo chiedono rispondo sempre che è impossibile deciderlo, ma sto seriamente valutando di usare Jullien come grimaldello universale. È questo, il mio libro preferito. Tié.
Un rimedio alla domanda opposta? Quale mai sarà il peggior libro del mondo? Auroro Borealo ci viene in soccorso con Il libro brutto dei libri brutti (Blackie).
Mi sono di certo dimenticata almeno 37 tomi che in realtà avrei voluto includere ma spero vivamente di avervi risolto qualche grana – o almeno di avervi indicato una valida pista. Se ci avete preso gusto o vi va di espandere le opzioni, qui trovate le edizioni passate dei listoni di Natale:
Per i bambini e le bambine, vi incoraggio a consultare questa lista, la carrellata tematica sui mezzi di trasporto e i mezzi pesanti, la raccolta degli atlanti (e dintorni) e il focus sugli insetti.
Per un approccio estremamente funzionale e sintetico a quello che di consultabile c’è qui sul blog nella sezione LIBRI o nei circoletti dell’Instagram, ecco il link generale a tutte le vetrine. Sì, le aggiorno man mano e senza soluzione di continuità.
Vi bacio, vi ringrazio per l’attenzione e vi auguro efficaci soluzioni a ogni dilemma regalifero. Evviva!


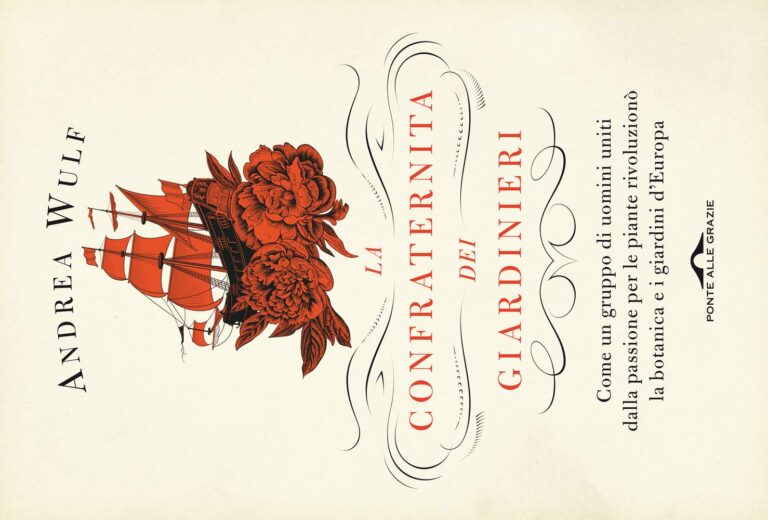
 Con
Con 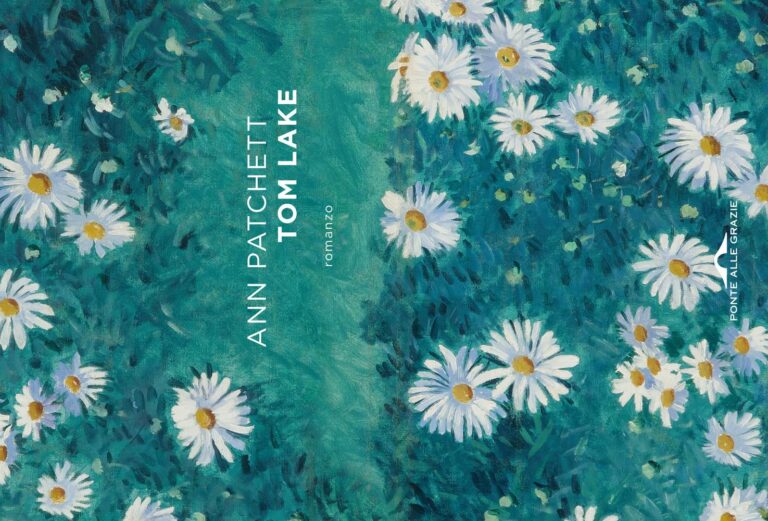


 Jean-François Champollion diventerà il vostro nuovo spauracchio durante quei tremendi momenti di smarrimento del tipo “maledizione, non ho ancora combinato niente nella vita… e ormai è tardi!”. Ebbene, Champollion decifrò la Stele di Rosetta a 20 anni, devastando la nostra autostima ma consegnando al contempo al mondo, nel 1822, la chiave per restituire voce ai monumenti di una civiltà intera, rimasti muti per millenni insieme al resto dell’abbondantissimo lascito documentario disseminato tra Alto e Basso Nilo. Io, a 20 anni, non riuscivo neanche a gestire un paio di collant, figuriamoci interpolare il greco, il demotico e i geroglifici, primeggiando tra gli studiosi della mia epoca in rapidità ed efficacia.
Jean-François Champollion diventerà il vostro nuovo spauracchio durante quei tremendi momenti di smarrimento del tipo “maledizione, non ho ancora combinato niente nella vita… e ormai è tardi!”. Ebbene, Champollion decifrò la Stele di Rosetta a 20 anni, devastando la nostra autostima ma consegnando al contempo al mondo, nel 1822, la chiave per restituire voce ai monumenti di una civiltà intera, rimasti muti per millenni insieme al resto dell’abbondantissimo lascito documentario disseminato tra Alto e Basso Nilo. Io, a 20 anni, non riuscivo neanche a gestire un paio di collant, figuriamoci interpolare il greco, il demotico e i geroglifici, primeggiando tra gli studiosi della mia epoca in rapidità ed efficacia.