Dunque, partiamo da una domanda che potrebbe sorgere spontanea: ma se mi è piaciuta la saga di Blackwater mi piacerà anche Gli aghi d’oro (in libreria con la traduzione di Elena Cantoni)? E chi può dirlo. Si tratta sempre di Michael McDowell – in questo suo molto ben confezionato ripescaggio dall’oblio – ma non ci sono chissà quanti altri punti di contatto. Sì, anche qui ci troviamo alle prese con vicissitudini e turpitudini di famiglia, anche qui possiamo crogiolarci nella deliziosa scelta di publishing di Neri Pozza – che continua ad affidare la copertina all’esimio Pedro Oyarbide – e anche qui c’è un certo gusto per il macabro, ma l’ambientazione è lontanissima dal limaccioso Perdido e manca anche l’adesione ai filoni “gotici”, magici o “mostruosi”. Qui siamo più nel territorio del poliziesco o del penny dreadful e l’intreccio personale – così come il peso che ha la caratterizzazione dei personaggi – viaggia su un binario all’apparenza molto più improntato alla funzionalità.
 Che succede? Siamo a New York nel 1882 e un abisso separa i rispettabilissimi benestanti dalla feccia tignosa dei bassifondi – zone in cui una casa, oggi, costa centordicimila paperdollari al metro quadro… ricordarlo mi pare sempre divertentissimo. Le due categorie umane sono qua rappresentate dalla stirpe dell’inflessibile giudice Stallworth – repubblicano di ferro e fan sfegatato delle impiccagioni – e dalla famiglia di Black Lena Shanks, ricettatrice astuta, potente e a suo modo assai rispettata. Lei e il giudice hanno dei trascorsi non proprio idilliaci e sarà un omicidio all’apparenza casuale – come tanti se ne verificano nei quartieri del vizio – a riportare a galla gli antichi rancori. Gli Stallworth mirano a migliorare la propria posizione ergendosi ad arbitri assoluti di virtù, scatenando una campagna pubblica contro il malaffare del Triangolo Nero. Black Lena, che non ama il clamore e vuole continuare serenamente ad occuparsi degli affaracci suoi, dovrà mettere il proprio acume al servizio della vendetta. Tra oppiomani catatonici, gioielli, bambini inquietanti, gole tagliate, bische, mignottoni, dame di carità, scrofolosi e materassi infestati dai pidocchi, l’ombra lunga del Triangolo Nero finirà per lambire i quartieri altolocati, smascherando l’ipocrisia e la grettezza dei più ferventi difensori della rettitudine.
Che succede? Siamo a New York nel 1882 e un abisso separa i rispettabilissimi benestanti dalla feccia tignosa dei bassifondi – zone in cui una casa, oggi, costa centordicimila paperdollari al metro quadro… ricordarlo mi pare sempre divertentissimo. Le due categorie umane sono qua rappresentate dalla stirpe dell’inflessibile giudice Stallworth – repubblicano di ferro e fan sfegatato delle impiccagioni – e dalla famiglia di Black Lena Shanks, ricettatrice astuta, potente e a suo modo assai rispettata. Lei e il giudice hanno dei trascorsi non proprio idilliaci e sarà un omicidio all’apparenza casuale – come tanti se ne verificano nei quartieri del vizio – a riportare a galla gli antichi rancori. Gli Stallworth mirano a migliorare la propria posizione ergendosi ad arbitri assoluti di virtù, scatenando una campagna pubblica contro il malaffare del Triangolo Nero. Black Lena, che non ama il clamore e vuole continuare serenamente ad occuparsi degli affaracci suoi, dovrà mettere il proprio acume al servizio della vendetta. Tra oppiomani catatonici, gioielli, bambini inquietanti, gole tagliate, bische, mignottoni, dame di carità, scrofolosi e materassi infestati dai pidocchi, l’ombra lunga del Triangolo Nero finirà per lambire i quartieri altolocati, smascherando l’ipocrisia e la grettezza dei più ferventi difensori della rettitudine.
McDowell riproduce gli stessi meccanismi di morbosa curiosità che la cronaca nera – resa nella sua crudezza e nella sua ricerca esasperata del sensazionalismo – scatena nel romanzo. È una forma di “commento” e di citazione sfiziosa, va detto. Tanto spazio è lasciato al sordido e a una vasta gamma di espedienti criminali, ma l’intreccio è ben lontano dal risultare miracoloso. La ricostruzione dell’ambiente è suggestiva ma calcatissima e si mangia i personaggi, che sono incarnazioni schematiche ed essenziali di un ventaglio di disvalori che superano le identità di classe. Il ribaltamento di prospettiva che se ne ricava è gustoso e, come da copione, si tifa per la vendetta… anche se ci si arriva con poco slancio. Black Lena e il suo clan di donne a loro modo estremamente talentuose ricordano la struttura matriarcale che ha plasmato le sorti dei Caskey e, pur trovando apprezzabilissima questa “abitudine” di McDowell di mettere in mano alle femmine il potere, qua mi è sembrato di veder transitare delle figurine che compensano lo scarso spessore con una stravaganza da freakshow.
Per sintetizzare: pensavo meglio? Pensavo meglio. Ci manchi, MaryLove. Eri più cattiva te.

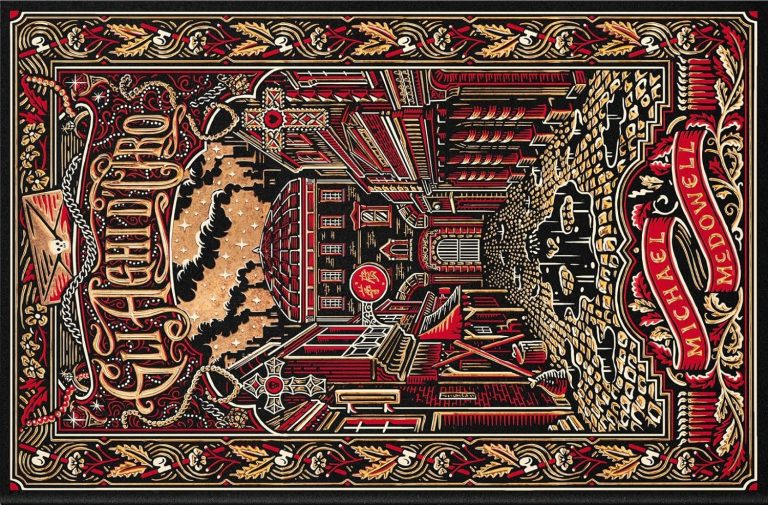
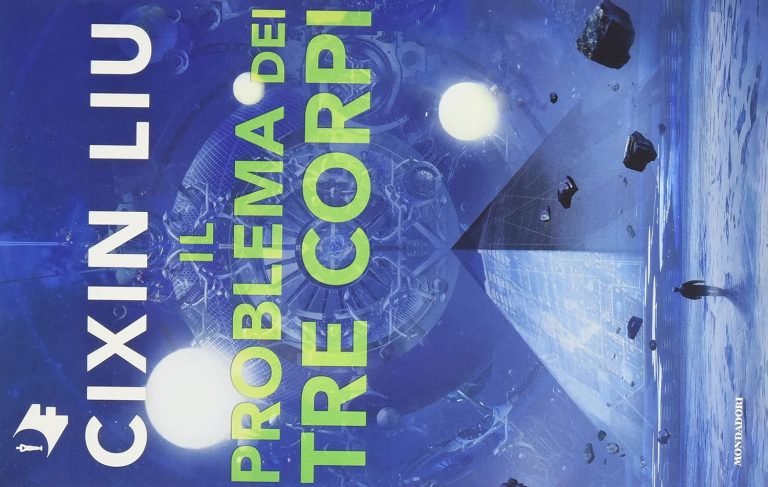



 Haratischwili ha trascorso l’infanzia in Georgia negli anni Novanta e abita in Germania dal 2003. Anche Niza, la sua narratrice e una delle “vite” del
Haratischwili ha trascorso l’infanzia in Georgia negli anni Novanta e abita in Germania dal 2003. Anche Niza, la sua narratrice e una delle “vite” del 
 Reduci dalla NOTEVOLE mole di 4321 – che possiamo aver amato o molto ammirato o possiamo magari ricordare in prevalenza per la fatica che ci ha fatto fare -, trovarsi alle prese
Reduci dalla NOTEVOLE mole di 4321 – che possiamo aver amato o molto ammirato o possiamo magari ricordare in prevalenza per la fatica che ci ha fatto fare -, trovarsi alle prese 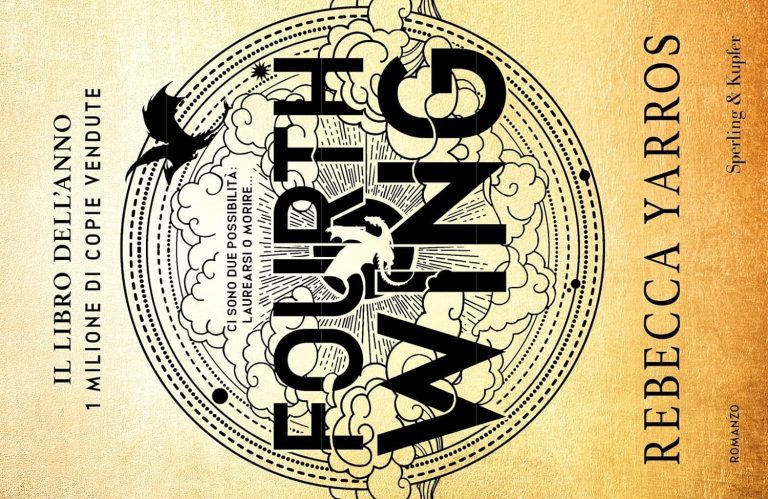
 Violet, con qualche comprensibilissima piva nel sacco e la certezza quasi matematica dell’annientamento, è costretta a obbedire e il romanzo la segue mentre fa del suo meglio per sopravvivere in quest’accademia piena di sadici, megalomani, rosiconi, attaccabrighe e traditori della patria. Anzi, di figli e figlie dei traditori della patria.
Violet, con qualche comprensibilissima piva nel sacco e la certezza quasi matematica dell’annientamento, è costretta a obbedire e il romanzo la segue mentre fa del suo meglio per sopravvivere in quest’accademia piena di sadici, megalomani, rosiconi, attaccabrighe e traditori della patria. Anzi, di figli e figlie dei traditori della patria.
 Che succede, in sintesi?
Che succede, in sintesi?



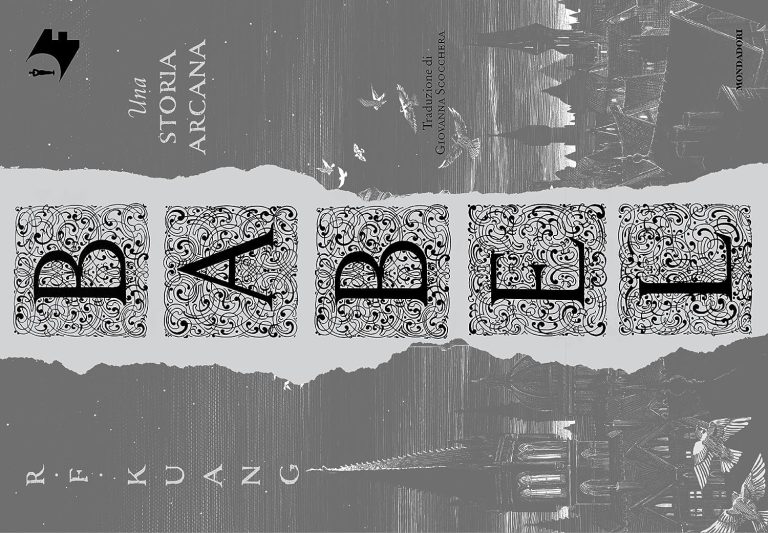
 Cosa succede?
Cosa succede?
