Di gender-gap nelle professioni tecnico-scientifiche e nella ricerca d’ambito STEM si parla in abbondanza ancora oggi, quindi figuriamoci com’era l’andazzo negli anni Sessanta. In Lezioni di chimica – uscito in italiano per Rizzoli con la traduzione di Anna Rusconi – Bonnie Garmus sceglie quell’epoca lì per la sua Elizabeth Zott, chimica autorevolissima e signorina con zero voglia di allinearsi al modello della casalinga suburbana. La storia di Zott è una specie di ripasso delle rivendicazioni femministe di base perché, per quanto la protagonista aborri la condizione di moglie e madre, la platea che più le darà credito sarà proprio quella. Come ci arriva? Con la TV.
 Zott trova un lavoro in un istituto di ricerca popolato da sgobboni e opportunisti che dispone di un unico vero genio. Questo Calvin Harris è un tipo strambo, che socializza poco e ha la fama di legarsi al dito anche il più minuscolo sgarbo. I due, tra un becco Bunsen e l’altro, si innamorano e trovano il modo di essere intelligentissimi insieme. Destano gran scandalo, ovviamente, perché convivono senza essere sposati e lui ha l’ardire di trattarla anche come una collega vera. Creano una famiglia atipica – che riscatta entrambi dal disastro dei loro nuclei di provenienza – , ma nel loro microcosmo tutto funziona….. fino a un cataclisma improvviso. Che ne sarà di Zott? E della figlia che non ha mai voluto ma le è rimasta sul groppone?
Zott trova un lavoro in un istituto di ricerca popolato da sgobboni e opportunisti che dispone di un unico vero genio. Questo Calvin Harris è un tipo strambo, che socializza poco e ha la fama di legarsi al dito anche il più minuscolo sgarbo. I due, tra un becco Bunsen e l’altro, si innamorano e trovano il modo di essere intelligentissimi insieme. Destano gran scandalo, ovviamente, perché convivono senza essere sposati e lui ha l’ardire di trattarla anche come una collega vera. Creano una famiglia atipica – che riscatta entrambi dal disastro dei loro nuclei di provenienza – , ma nel loro microcosmo tutto funziona….. fino a un cataclisma improvviso. Che ne sarà di Zott? E della figlia che non ha mai voluto ma le è rimasta sul groppone?
Di fatto estromessa e scacciata da quei mentecatti dell’istituto, Zott coglierà al balzo un’occasione economicamente redditizia e, dato che è pure bella e magnetica, diventerà la conduttrice di Supper At Six, un programma di cucina di fascia pomeridiana. Il network sperava di aver assunto una rassicurante massaia, ma Zott trasformerà lo show in una lezione di chimica….. e di proto-femminismo.
Allora, l’ho trovato piacevolissimo, nonostante Zott sia un personaggio che risulta paradossalmente statico. Certo, si riadatta agli accidenti e alle opportunità della vita, ma la sua inflessibile fedeltà a una vocazione scientifica e al rifiuto di qualsiasi convenzione o compromesso sembrano far parte del suo patrimonio genetico, prendere o lasciare. È corretto, mi vien da dire, che Zott sia così, proprio perché il contesto a cui appartiene si aspetta femmine docili, obbedienti, prive di opinioni e di ambizioni, decorative e malleabili, ignoranti e inoffensive: Zott non ha la minima intenzione di rispondere alle aspettative, ma si aspetta invece che sia il mondo a cambiare e lo affronta come se toccasse a lei fare da prototipo, mostrando che un’altra strada dovrebbe essere possibile. Certo che è una specie di monolito alieno, perché se si ammorbidisse anche solo di tanto così il bel soufflé che è questo romanzo si sgonfierebbe, rassegnandosi a somigliare al compromesso imperfetto e quasi sempre iniquo dei nostri percorsi “veri”.
Zott prende sul serio le donne che la guarderanno – prima allibite e poi sempre più gasate – alla TV, le tratta come degli esseri umani capaci e autorevoli, le istruisce e le incuriosisce. E lo fa da persona che condivide il medesimo “svantaggio” di partenza e che ha pagato a caro prezzo quell’intransigenza che, almeno da fuori, risulta così d’ispirazione, così “potente”. Zott non cambierà nulla, dalla mattina alla sera, ma nell’improbabile esperimento che è la sua esistenza non c’è spazio per i vecchi dogmi. Chi l’ha detto che non ci arriviamo, che siamo meno brave, che il nostro posto è solo questo? Voi? Sarebbe meglio verificarlo, se non vi dispiace. Forza, il laboratorio è per di qua – sembra una cucina? Guardate meglio.
[Sì, sono consapevole dell’esistenza della serie TV ma non l’ho ancora vista, anche se mi garberebbe molto capire com’è. Il fatto che sia prodotta da AppleTV fa ben sperare.]



 Una buona intervista si fa se il soggetto interrogato ha qualcosa da dire e se si fanno le domande giuste. Un’intervista *eccellente* è, in realtà, uno scambio tra due persone che si riconoscono e si rendono disponibili alla reciproca curiosità, scordandosi gerarchie e ruoli per creare qualcosa di autonomo, che per ricchezza sta in piedi da solo e aggiunge un tassello in più rispetto ai punti di riferimento di partenza. Che uno scrittore intervisti bene un altro scrittore non è affatto scontato – genera attenzione perché ti porti a casa due grandi nomi in una botta sola, ma bisogna appaiarli con buonsenso. E anche in quel caso non sai come andrà a finire.
Una buona intervista si fa se il soggetto interrogato ha qualcosa da dire e se si fanno le domande giuste. Un’intervista *eccellente* è, in realtà, uno scambio tra due persone che si riconoscono e si rendono disponibili alla reciproca curiosità, scordandosi gerarchie e ruoli per creare qualcosa di autonomo, che per ricchezza sta in piedi da solo e aggiunge un tassello in più rispetto ai punti di riferimento di partenza. Che uno scrittore intervisti bene un altro scrittore non è affatto scontato – genera attenzione perché ti porti a casa due grandi nomi in una botta sola, ma bisogna appaiarli con buonsenso. E anche in quel caso non sai come andrà a finire. 
 In piena Guerra Fredda, il campione sovietico in carica Boris Spasskij è chiamato a difendere il titolo contro lo statunitense Bobby Fischer, giocatore geniale ma imprevedibile, un eremita inghiottito di mille fissazioni e nemico di ogni convenzione, matto in senso metaforico ma molto probabilmente anche clinico. Fischer è “matto” per noi che non siamo stati baciati dal talento per gli scacchi ma è matto anche per chi quel mondo lo abita e assiste con meraviglia e sgomento alle sue feroci partite – sperando sempre di non trovarselo davanti.
In piena Guerra Fredda, il campione sovietico in carica Boris Spasskij è chiamato a difendere il titolo contro lo statunitense Bobby Fischer, giocatore geniale ma imprevedibile, un eremita inghiottito di mille fissazioni e nemico di ogni convenzione, matto in senso metaforico ma molto probabilmente anche clinico. Fischer è “matto” per noi che non siamo stati baciati dal talento per gli scacchi ma è matto anche per chi quel mondo lo abita e assiste con meraviglia e sgomento alle sue feroci partite – sperando sempre di non trovarselo davanti.

 Comunque,
Comunque, 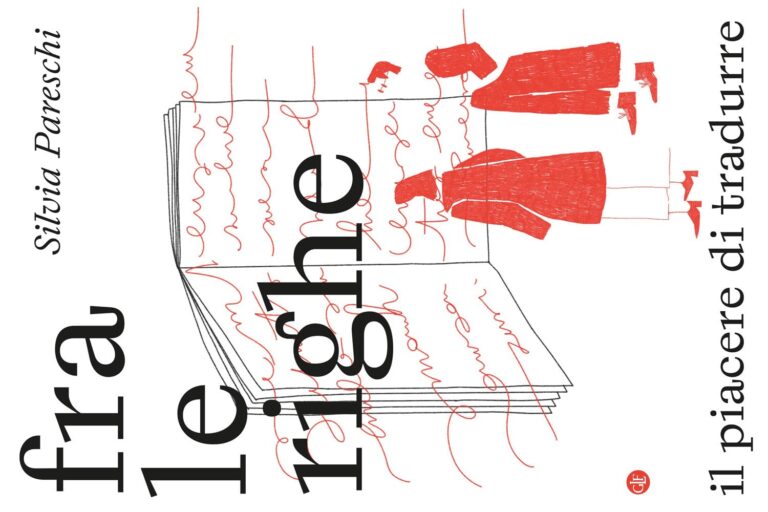
 Tra autobiografia professionale e collezione di dilemmi (risoltissimi), Pareschi condensa in
Tra autobiografia professionale e collezione di dilemmi (risoltissimi), Pareschi condensa in 
 Lacey è molto abile e anche molto paziente. Il circo che tira in piedi con
Lacey è molto abile e anche molto paziente. Il circo che tira in piedi con 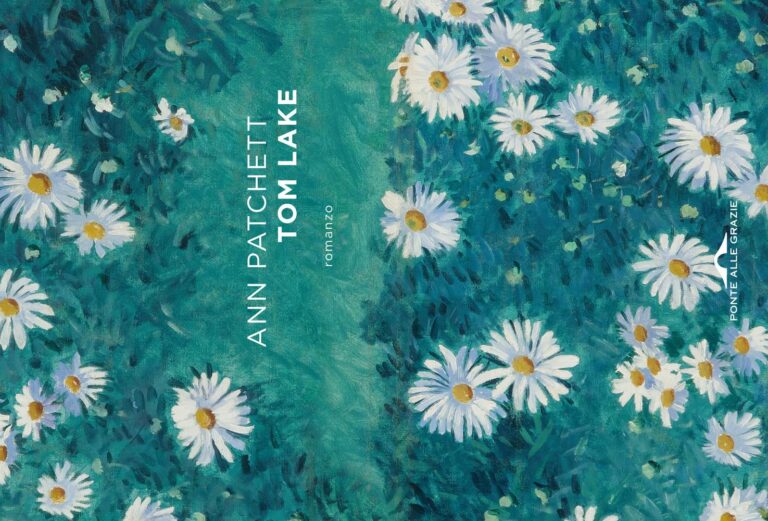

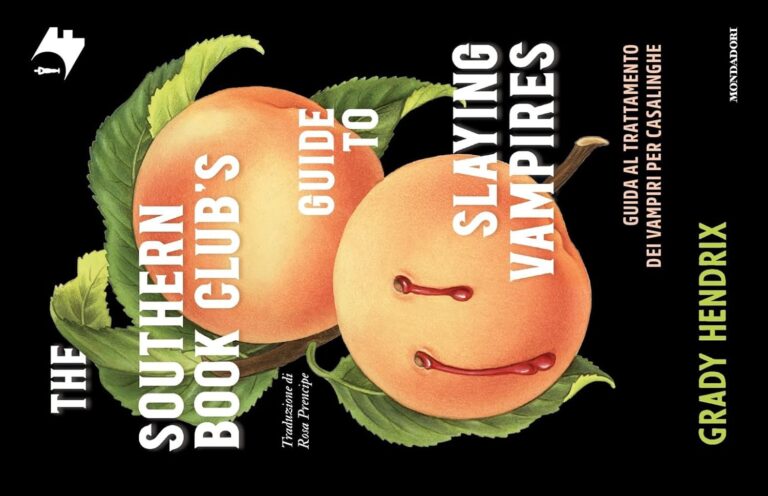

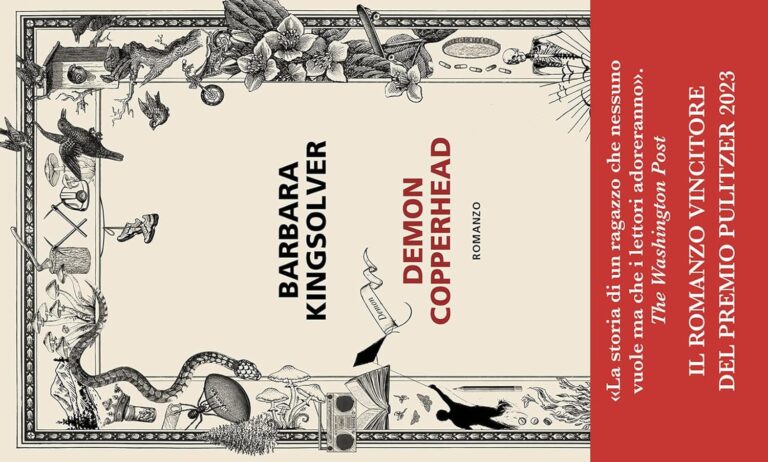
 Demon nasce senza tante cerimonie sul pavimento di una casa mobile, da una diciottenne con già alcuni percorsi di disintossicazione (non molto ben riusciti) alle spalle. L’unico dono che il destino pare tributargli sono dei vicini che diventano una sorta di seconda famiglia. Pure loro sono hillbilly da manuale, ma in confronto a Demon e a sua madre – privi di mezzi, privi di radici, di direzione o di magici piani a lungo termine – sembrano il Rotary Club di Corso Magenta. Demon oscilla tra un’iperconsapevolezza della propria condizione di svantaggio “materiale” e una struggente capacità di assorbimento delle disgrazie. Non solo cerca di cavarsela, ma resta “intero”, anche se chi dovrebbe prendersi cura di lui non si dimostra mai all’altezza della situazione, anzi.
Demon nasce senza tante cerimonie sul pavimento di una casa mobile, da una diciottenne con già alcuni percorsi di disintossicazione (non molto ben riusciti) alle spalle. L’unico dono che il destino pare tributargli sono dei vicini che diventano una sorta di seconda famiglia. Pure loro sono hillbilly da manuale, ma in confronto a Demon e a sua madre – privi di mezzi, privi di radici, di direzione o di magici piani a lungo termine – sembrano il Rotary Club di Corso Magenta. Demon oscilla tra un’iperconsapevolezza della propria condizione di svantaggio “materiale” e una struggente capacità di assorbimento delle disgrazie. Non solo cerca di cavarsela, ma resta “intero”, anche se chi dovrebbe prendersi cura di lui non si dimostra mai all’altezza della situazione, anzi.
